Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare.
Eraclito

Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare.
Eraclito

Figure di donne che hanno attraversato storie di criminalità, considerate di cattivo esempio, hanno rappresentato una terrificante incarnazione del male, da questo ne deriva la rimozione delle loro vite e della loro sofferenza, in questo post vi è un briciolo di verità strappata alla polvere degli archivi.
Nella lingua italiana molti sostantivi, che indicano attività o mestieri, sono stati concepiti, nei vari momenti dell’elaborazione della lingua, in canoniche ed esclusive desinenze maschili: “dottore”, “avvocato”, “brigante”. Termini in cui la presenza della donna era esclusa a priori. Quando poi accaddero mutamenti sociali tali da consentire uno straripamento femminile entro argini inconsueti, le intruse vennero bollate anche linguisticamente, e furono, con un fondo di ironia ed eclatante cacofonia, non le dottore ma le dottoresse, non le avvocate ma le avvocatesse, non le briganti ma le brigantesse. Così nacque, in un clima di leggenda, la Papessa, e alla moglie del Doge di Venezia fu affibbiato il ridicolo “Dogaressa”… Ma se le infrazioni a cui si è chiamati a dare un nome sono a volte componibili entro schemi sociali accettabili, altre volte, tutti gli anni del mondo non riusciranno ad escludere l’esecrazione, il disgusto, e la paura. Questa nota è un pretesto per introdurre la vita e la morte delle rimosse e rifiutate brigantesse, il cui nome pare quasi uno scherzo, e la cui storia fu annullata nella Storia che decise di farle scomparire.

Quando l’Italia dichiarò guerra al sud
Nel 1860 viene unificata l’Italia, anche se ci vorranno ancora dieci anni per sciogliere nodi fondamentali, quali ad esempio la Questione Romana. E il Primo Ministro Cavour, prendendo la parola nel primo parlamento unitario, nel ’71, dirà che lo sapevano anche i bambini, che fatta l’Italia bisognava fare gli italiani. Ciò che i bambini ignoravano, poiché nessuno glielo diceva, è che, per imporre il dominio dello Stato Piemontese sul Meridione, non si esitò a dichiarare una nuova guerra: quella per l’egemonizzazione. I soldati italiani furono mandati a placare col sangue i tumulti popolari di quanti, da Roma in giù, non si sentivano rappresentati da uno stato “francese”, che imponeva tasse, obbligava i loro figli al servizio di leva obbligatorio, poneva la sua giurisdizione su tutte le forme amministrative. Se alcune menti liberali “illuminate” fecero inchieste approfondite sui disagi del Sud é se ai problemi del brigantaggio, il Parlamento dedicò ore di seduta, la linea che fini col prevalere fu la più dura che si potesse immaginare: la legge Pica istituì tribunali militari, novantamila soldati furono mandati a combattere l’eversione, le province meridionali furono in breve tempo “pacificate”. Fu detto che il brigantaggio era un fenomeno “reazionario”, ispirato e sovvenzionato dalla spodestata dinastia borbonica: in realtà, se questo fu vero, lo fu solo in quanto rifiuto del Governo nuovo e lontano, e fu insieme a molte altre verità: verità contraddittorie, e difficili da ricostruire, dal momento che poche sono le reali testimonianze dei briganti (spesso estorte negli interrogatori), gli osservatori che allora ne scrissero, agirono sempre nell’ambito di un’ottica criminalizzante e giustificatoria degli eccidi compiuti dallo Stato. Quello Stato che, come scrisse Gramsci, “ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi i contadini poveri che gli scrittori salariati tentarono infamare col marchio dei briganti”…
La sensazione che qualcosa non quadrava, che mancava, si scopre guardando foto delle brigantesse: con il fucile in mano; le espressioni severe, ma non tristi. Tutte le foto sono state scattate da un fotografo dell’esercito, al momento dell’arresto delle donne, e nei loro sguardi, se c’era sfida, non era una sfida “forzata”. Traspariva, invece, una grande naturalezza. Qualcuna poi era stata fotografata dopo l’uccisione, ed era nuda: uno sfregio in più.” una repressione in più, più voglia selvaggia di cancellare. Le notizie sulle donne briganti sono poche, difficilissimo è ricrearne un percorso, perché tutti hanno cercato di rimuoverle. Nelle memorie degli ufficiali del tempo, dei cronisti prezzolati, degli pseudo-scienziati, le tracce del loro passaggio sembravano non esistere. Addirittura la smania puntigliosa di Lombroso le estromette: dopo aver analizzati i crani dei briganti caduti per dimostrare i presupposti delle sue teorie fisiognomiche, ebbe a dire, in appena due righe, che fra i briganti c’erano anche delle donne, ma erano talmente bestiali e tremende che è meglio dimenticarle per sempre.

Una storia di silenzi
Così ne parlarono, non parlandone. Resero entusiasmante e malinconico lo sforzo di chi, oggi, va a cercarne le tracce umide di sangue e di vita. Bisogna chiarire da subito però alcune cose: trovare tracce di vita dimenticata è sempre, per chi fa ricerca, opera affettuosa, quasi di neofita, è un appassionato protendersi su un arco di storia. Ed è ricerca anche dolorosa, per superare la fitta fatica della polvere. Storie di donne rimosse: è un episodio, ed è già universale, la coscienza dell’emarginazione delle donne è ormai un’organizzazione mentale, uno schema in cui. continuamente, vanno a confluire i volti decifrati risorti dal nulla.
Non diciamo che, come sostiene Prancamaria Trapani (autrice di un libro dedicato alle brigantesse) “il brigantaggio femminile fu un fenomeno psicologicamente autonomo collaterale e distinto rispetto al brigantaggio maschile… Una prima ribellione femminista allo stato di soggezione atavico e tradizionale della donna… una sorta di suffragismo del subconscio, addirittura un fenomeno di parossismo asociale e anti-legalitario… “.
E violenza ed antistoricismo attribuire categorie postume di esperienze soltanto consce, forse, di “scellerata” coscienza della giustizia. Né compiamo quel terribile, nefasto rito dell’attualizzazione tracciando paralleli inverosimili e contorti tra le donne briganti di allora e le donne oggi nella lotta armata. Né mi sembra il caso di improvvisare storie di eredità morale, o di continuità ideali che travalichino il semplice, biologico, tremendo costume dell’”attitudine” di subire il silenzio: poiché significherebbe appropriarsi, riutilizzare.

Michelina morì digrignando i denti
Jacopo Gelli ebbe “la buona ventura di mettere le mani sopra una quantità importante di carte documentarie”, abbondonate da un’organizzatore del brigantaggio. Così scrisse Banditi briganti e brigantesse nell’800: con la prosa in auge nel ’31. e con il filtro delle sue personali interpretazioni.
É lui a parlare di Gioconda Marini. Maria Capitanio e Carolina Casale, catturate con la banda di Giacomo Ciccone: “Le donne vestivano abiti maschili alla foggia brigantesca e come briganti avevano sparato con accanimento contro i nostri soldati, finché, circondate da ogni parte, furono disarmate con la violenza, dimostrandosi decise a non arrendersi. La prima a svelare il suo sesso fu la Gioconda Marini da Cervinara, sorella del capobanda Michele Marini. Sentendosi apostrofare con dileggio da taluni soldati per l’inconsueto sviluppo del ventile disse di essere femmina incinta di sette mesi in procinto di diventar madre per opera del suo amante, Alessandro Pace.
Indicava poi, due altri dei briganti cattatati, al par di lei femmine. Ed erano la Capitanio di San Vittore, amante del brigante Antonio Luongo, rinomata per la risolutezza nell’attaccare e svaligiare le persone, e la crudeltà nell’eseguire le decisioni del capobanda Ciccone, o per soddisfare la propria libidine di sangue la cui vista la esalatava. L’altra era la Casale, di Cervinara, amante del brigante Suppiello, essa pure da quattro mesi nell’attesa della maternità. La ferocia di queste brigantesse era proverbiale. Però la palma spetta a Cristina Cocozza, amante del capobanda Colamattei, catturata il 13 aprile 1868 da una colonna del 68° fanteria. La cattura di questa donna durante l’attacco nei pressi di Vallerotonda, costrinse il Colamattei a costituirsi, lasciando nelle mani dei nostri soldati una quantità di armi e di munizioni, molte vettovaglie e quadrupedi, abbandonati nella fuga dai briganti. Queste donne drude dei malandrini, erano le più sicure confidenti ed informatrici delle bande, pronte a morire piuttosto che tradire i loro. Esse, ora camuffate da briganti, ora da pastori, ora nel loro abito di donna andavano e venivano inosservate, portando notizie precise e sicure sui movimenti delle nostre truppe, o rifornimenti di munizioni, che celavano sotto le ampie sottane, ai compagni”.
Ma non tutte le “drude” avevano questa vocazione alla fedeltà. Gelli ci racconta di Mariannina, la donna di Caruso. Il quale Caruso, al termine di numerose battaglie, “fu preso caldo caldo nel suo nido d’amore, mentre dormiva sotto la vigile custodia della sua Mariannina. Egli è, che la cattura non fu come si suol dire: spontanea. I diavoli della gelosia, o quelli dell’oro o gli altri della vendetta dovevano averci messo lo zampino. Caruso da più giorni scappava, come cervo davanti a muta, all’inseguimento dei nostri soldati, che non gli davano requie. Stanco, sfinito, disfatto, estenuato, dalla fuga perenne e dai continui allarmi cedette al bisogno di riposo, sebbene sapesse i regolari e le guardie nazionali poco lontani dal suo rifugio. Si addormentò, sicuro che la vigile compagna, la cara Mariannina, lo avrebbe svegliato in caso di pericolo. Meglio Caruso non poteva affidarsi!”
La sensibilità maschile di Gelli, peraltro sempre schierato con tutto sé stesso dalla parte dell’esercito e della legge, questa volta ha lievi sussulti di fratellanza. Il bandito tradito dalla donna è un cervo inseguito, è l’unico brigante a ricevere una descrizione “umana”… Per Mariannina, naturalmente, il metro è diverso, e le accuse “femminili”: “Data la passione per la vita avventurosa della Mariannina, non è escluso che abbia consolato tanto il Caruso quanto Nico Nanco (celebre bandito dell’epoca)”. Poco più in là, troveremo data con non-chalance, la notizia che Caruso aveva ucciso il padre di Mariannina. Ed è ozioso discutere se le notizie qui riportate siano tutte false o tutte manipolate: ciò che emerge con chiarezza è l’esistenza di un diverso criterio per descrivere, nell’ambito della stessa “criminalità”, gli uomini e le donne. Per le quali donne la trasgressione è sempre accompagnata da valutazioni di tipo morale, in cui si rintracciano tutte le valutazioni affastellate nello stretto spazio tra le definizioni: madre-moglie-prostituta. Della banda di Schiavone “facevano parte due donne: Filomena Potè, amante titolare, e Rosa Tardagno, diremo amante… supplementare. L’una e l’altra si eguagliavano nella crudeltà, nella temerarietà senza pari e nell’odio dei nostri soldati. Se taluni di questi nostri cari figlioli cadeva nelle mani di quelle due male femmine, era certo di finire i suoi giorni tra le sofferenze più oltraggiose e atroci!” In un’occasione poi il Gelli è costretto a nominare l’esistenza di una capo-brigante. Devono comunque essercene state delle altre, per le quali l’esercizio del comando, rispettato e tenuto in considerazione dai loro compagni, è considerato in qualche modo “Stimmata” di una crudeltà eccessiva tra le eccessive crudeltà dei briganti. Francesco Guerra non era un vero capo: “La sua banda non era numerosa, appena una decina di masnadieri, come lui decisi a tutto, i quali, compreso il Guerra, obbedivano ciecamente ad una donna segaligna, brutta, tutta nervi e volontà, Michelina Di Cesare, da Caspoli, druda del Guerra”. La banda infine affrontò, sul Monte Marrone, la sua ultima battaglia, “alla testa di quell’anima dannata della Michelina”. I colpi dell’esercito stermineranno questo gruppo. “La rea donna aveva combattuto come una leonessa. Colpita al capo, la femmina morì digrignando i denti per la rabbia di essere stata vinta e non per l’orrore dei misfatti compiuti”. Ma la bellezza non ispira più simpatia, anzi, tutt’altro: Maria
Oliverio “passava per essere la più bella del luogo, con il suo abbondante casco di capelli corvini, e con gli occhi nerissimi rispecchianti un’anima altera e decisa. Il Monaco un giorno venne a questione con un proprietario del paese e, in un momento d’ira, imbracciò lo schioppo, sparò e lo uccise. Per sottrarsi all’arresto si immacchiò e quindi si fece brigante, raccogliendo intorno a sé un buon numero di malviventi. Mentre il marito faceva, suo malgrado, uccel di bosco, la moglie venne a conoscere che la sorella era stata amante di lui. Non tollerando che essa avesse vissuto o potesse vivere di nuovo di furto sul suo amore, per gelosia aspra decide di vendicarsi. Con un pretesto fece dormire in casa sua la sorella e durante il sonno la crivellò di ferite con un coltello, onde ne morì. Compiuta la vendetta raggiunse il marito nella macchia e, vestitasi da uomo brigante, in breve divenne la dominatrice di tutta la banda”. Finirà condannata a morte per il tradimento di uno dei suoi.

I misteriosi rapimenti di Concetta
La scelta di riportare così ampi stralci delle descrizioni del Gelli nasce da due ordini di considerazioni: il primo è quello di tracciare, prima di andare avanti, praticamente tutto il panorama delle notizie riportate sulle brigantesse, e delle interpretazioni di esse date, poiché quella del Gelli è l’unica raccolta di “aneddotica” in proposito; il secondo è di far parlare questo testimone così inquadrato e di far raccontare a lui stesso l’infinita malafede della storia, che, se in questo caso esalta all’ennesima potenza il disgusto per le donne, in tutti gli altri casi, negli innumerevoli volumi e saggi scritti sul brigantaggio, ne cancella la presenza.
Così Anna Cartabelotta, Rosa Reginella incinta di sette mesi e condannata a venti anni, Maria Patulli, Generosa Cardomone, Filomena Cianciarullo in procinto di maternità, Chiara Nardi e tante altre, non hanno che il nome e l’indicazione del brigante, che si supponeva loro amante, per disegnar loro un volto umano.
Cercando negli archivi polverosi, massacrandosi gli occhi per decifrare grafie illeggibili e inchiostri stinti dal tempo, si ritrova qualche storia di donna, per quanto almeno è possibile ricostruire la storia dai verbali dei processi, in calce ai quali la croce per firma tracciata con mano tremante da tutto il senso e l’orrore di un’emarginazione antica.
Le briganti che emergono da questi documenti sono molto lontane dalla ferocia che il Gelli attribuisce loro. Per fortuna o per sfortuna non saprei dire, per riprova però, questo si, delle profonde bugie riportate nei tempi. E così Maria Giovanna Simoncelli. contadina, di anni 22, appare in giudizio insieme a Michele Angelo Cipriano di anni 24. Lui dice di essere diventato brigante “per i bistrattamenti ricevuti dal suo padrone Antonio Santoro”, lei invece racconta che “amoreggiando con Cipriano fin dall’aprile 1863 fu poi arrestata come sospetta manutengola e poi mentre stava in paese un tal Michelangelo Majorano andò per ben tre volte a persuaderla perché seguisse il suo innamorato, ma essa essendo restia non voleva”. La storia termina con un rapimento: Maria Giovanna viene attirata in un tranello e portata da Cipriano. E questo è quanto pare, lei ammetta, perché “alle altre domande è negativa”.
Dalle carceri di Castelbaronia, scriveranno all’avvocato per chiedere direttive: è stato infatti ordinato il trasferimento della Simoncelli ad Avellino, ma “si presenta la difficoltà che è incinta di sette od otto mesi, perciò la prego scrivermi se deve essere tradotta costei in Avellino subito, o se crede meglio attendere l’esito della gravidanza”.
Una nuova lettera, una quindicina di giorni dopo, dichiarava che Maria Giovanna era “impossibilitata a rimanere in carcere”, e chiedeva che “fosse data in consegna fino allo sgravio, poiché veramente soffre delle continue convulsioni”.
Le immagini inedite che trapelano dai verbali sono lontane anni luce da quelle stigmatizzate da Gelli, sono a volte cariche di profondo orrore, quasi sempre delineano delle vittime. E la vittima più orrorifica è senza dubbio Angiolina Somardani. “druda” di Mauro Mugnolo, e da lui, confessa il “pentito” Curcio, ammazzata. L’autopsia sul suo cadavere rivela una furia scatenata e di segno molto preciso: ha ferite sulla testa, nel viso, sopra la ghiandola mammaria destra, sotto la mammella destra, e nel torace, trasversalmente all’ombelico.
Due vittime, una dei briganti e l’altra della legge, sembrano essere Varchione Concetta e Marri Luigia, imputate “la prima di brigantaggio e la seconda di complicità in detto reato “. Le notizie rintracciabili, specie nel caso di Concetta, appaiono contraddittorie, e difficili da comporre. Ma veniamo al caso. Le guardie circondano il villaggio Castelli per sorprendervi i briganti; arrestano Concetta, di anni 20, mentre fugge dalla casa di Luigia. “onde aveva pernottato la notte coi briganti”, “vestita da uomo con abiti poco comuni in questi paesi”. Segue una serratissima indagine sul conto di Concetta, che già era stata arrestata per nove mesi per quella che oggi si chiamerebbe “partecipazione a banda armata”.
Ma facciamo raccontare i fatti da lei: “Io venni catturata…, dai briganti capitanati da certo Pasquale Riccio che mi deflorò e col quale stetti sette mesi circa finché lui riuscì di fuggire ed andai a presentarmi a Napoli al generale Lamarmora, il quale mi fece processare nelle carceri di Cervinara, come mi fossi sgravata di un bambino, quindi venni tradotta a Campagna (…) indi posta in libertà e diretta con foglio di via a Cervinara venni nuovamente catturata dalla banda di Pasquale Mortone col quale stetti una ventina di giorni… “, ed il racconto prosegue spiegando che il Martone era stato istigato a catturarla da certi suoi conoscenti coi quali aveva avuto a che dire, e la storia, in realtà un po’ fumosa del doppio rapimento, insospettì moltissimo la Corte, ed anche il comandante dì distretto, il quale, parlando di lei dice che “poco tempo dopo che era uscita dalle carceri si faceva prendere dalla banda Martone… il che fa supporre che vi concorresse la sua volontà”. Ed il giudice Alfonso Rossi di Cervinara è ancora più esplicito: “da tempo veniva ricattata da un’orda brigantesca ignorandosi il luogo, e dal capobanda Pasquale Ricci venivale rapito l’onore, e posseduta dallo stesso per più mesi (…). E finalmente non debbo tacere che vuolsi pure che la Varichione (…) volontariamente si associa ad altra banda malfattrice che esisteva in questi monti… ”
Concetta discolpa del tutto Luigia, dicendo che i briganti erano entrati nella sua casa di soppiatto e che lei neanche era presente. La giunta municipale stende i suoi rapportini. E Maria Luigia è “già di pessima condotta sotto ogni rapporto, mentre la pubblica opinione la ritiene come in continuato contatto coi briganti, e che li riceveva a casa propria”.
Infine una serie di testimonianze a lei favorevoli, è l’aiuto di Concetta che, per discolparla totalmente, accusa del reato che Luigia è chiamata a scontare una vedova Rosa Mischiatello, che però è già riuscita a fuggire, riescono a discolpare totalmente Luigia dall’accusa di “manutengola”, cioè di “fiancheggiatrice” di briganti: una definizione che apre un ampio spaccato femminile in una storia parallela a quella sotterranea dei briganti, e sotterranea ancora più di questa. Manutengolo era chi portava viveri, chi riferiva dei movimenti delle truppe, chi accettava soldi per fare spese per conto dei briganti, chi li nascondeva, chi era insomma loro complice. A scopo “istruttivo”, le pene per queste persone erano fortissime, praticamente pari a quelle per brigantaggio vero e proprio, e le sentenze venivano affisse ai muri dei paesi “al terrore dei malvagi”.
Forse perché molte delle attività che si possono svolgere per aiutare un gruppo clandestino senza parteciparvi attivamente sono spiccatamente femminili, (dal lavare i panni all’essere, come più d’una volta alludevano i verbali, “donna di piacere”), le “manutengole” superano di gran lunga i “manutengoli”, e l’inquisizione scatenata contro di loro non dimentica mai di avere a che fare con donne…
Così Lucia Pisaniello, minore di anni 21, è costretta a scrivere questo aberrante “discarico”: “…Viene accagionata di essere stata donna di piacere dell’estinto famigerato Calabrese, e da una voce che circola anche fra gli ufficiali della guarnigione che risiede in Cervinara, che asseriscono che, il detto brigante Calbrese, dopo essere ucciso, fu trovato affetto da mali venerei. La supplicante per questo fatto domanda una perizia per mezzo di professori sanitari, i quali osserveranno la richiedente se trovasi pure infetta, ovvero conservi tuttora il pieno stato virginale”. Le saranno dati dieci anni, in considerazione della sua età. Sua madre ne prenderà venti.
La parentela con briganti, poi, è una sorta di predestinazione. Per esempio, quando fu arrestata Maria Maddalena Taddeo, il municipio del suo paese scrisse sul suo conto: “deve ritenersi di pessima condotta in quanto ai fatti di complicità al brigantaggio, perché essendo la stessa figlia e nipote dei briganti Taddeo non ha mancato fornirgli del bisognevole seguendoli per le montagne giusta la voce pubblica”. Maria Maddalena Taddeo era una donna perversa di anni 13! Alle parenti “più parenti”, cioè alle madri, si chiede, per amore o per forza, la delazione, in maniera, però, alquanto contraddittoria, poiché se Carmina Riccio, madre di Michele Cillo. “ha promesso’ sempre all’autorità di farlo presentare, ma giammai si è verificato, in conseguenza si crede che vi abbia avuto corrispondenza e connivenza”, Cioffi Diamante, madre dei Taddei. “è sempre stata negativa far presentare i figli, ed imprecava la madre di Cillo che voleva far presentare il figlio, quindi si presume connivenza”. Anche per tre donne di Bisaccia, Grazia Gervasio. Lucia Gentile e Antonia Fierro, si mobilita tutta la potenza inquisitoria. La sentenza le giudica favoreggiatrici, non senza aver scrutato con occhi maligni e attenti tutta la loro vita. Probabilmente tutta la volontà di scandagliare le loro esistenze nasce dal fatto che nel 1861, Francesco Gentile si era dato al brigantaggio. Ciò che è sicuro però è che nessuna sfera della loro esistenza sfugge all’analisi più impietosa. Nell’atto d’accusa contro di loro gli indizi sono già “prove”. Grazie alla testimonianza di un vedovo quarantenne, di un possidente di 63 anni, di un luogotenente della guardia nazionale e di un Economo Curato, si accerta dunque che “le imputate, le quali prima che il Francesco Gentile si desse nel 1861 al brigantaggio si trovavano nella estrema miseria, ebbero dopo tale epoca a condurre una vita comoda e agiata relativamente al loro stato; che la madre e la figlia Gentile si assentavano di sovente sul far della notte portandosi alla campagna d’onde non erano di ritorno che al mattino di buon’ora; che tali incursioni notturne venivano pur fatte dalla Fierro Antonia per portarsi a trovare il fratello brigante, ed il Francesco Gentile suo cognato, con cui faceva commercio adulterino; che le imputate furono vedute a lavare e fare asciugare camicie ed abiti da uomo, mentre non erano pubbliche lavandaie, e non avevano in casa uomini, cui potessero appartenere dette camicie ed abiti; che mentre prima del brigantaggio non riuscivano a pagare la pigione di casa, dopo tale epoca ebbero a pagare nel 1862 ducati 49 quale prezzo di una casa avuta in affitto… “.
Brigantesse, manutengole e drude che fossero, le donne di quei luoghi e di quegli anni parteciparono attivamente al brigantaggio. E tanta partecipazione non può che dimostrare che la loro fu una adesione viscerale, profonda, di donne, sprezzante, di emarginate, incazzate, di donne che amano, e non c’è da scandalizzarsi… a patto che non sia solo l’amore, troppo spesso sacrificale, a ricordare la lotta silenziosa, massiccia e vinta che esse portarono avanti. Trasmettendo la cultura, portarono in se stesse questo amore e lo tramandarono, amore che può diventare anche un disperato, dolente odio.

Storiografici e ideologici, quelli della storiografia “giacobina”, decisero di non dare spazio alla ricerca al mondo della controrivoluzione e delle insorgenze, nonostante la nascita della politica che si realizza in Italia nel corso del decennio rivoluzionario ha visto partecipi anche le masse degli insorgenti che dall’esperienza hanno maturato un’identità politica. Osservazioni condivisibili, ma la questione del contributo della Controrivoluzione ai processi di politicizzazione dei ceti popolari non elimina una differenza sostanziale tra i due campi, quello repubblicano, nelle sue diverse accezioni dal moderatismo al giacobinismo, e quello sanfedista. La differenza sta nel fatto che è il primo dei due campi a far entrare, pur con tutti i limiti e le contraddizioni da tempo analizzate dagli storici, i ceti popolari in una società basata sull’eguaglianza di fronte alla legge, emancipandoli dalla condizione di sudditi e trasformandoli in cittadini da formare politicamente. La controrivoluzione non formò cittadini ma fondò, semmai, i presupposti ideologici e mentali dello schieramento antidemocratico e antiliberale dell’Ottocento e del Novecento che fu al tempo stesso antirivoluzionario e antirisorgimentale.
La crisi dello Stato borbonico precipitò nella primavera del 1860 con la campagna siciliana, disastrosa per l’esercito e per il re. Le istituzioni del Regno implosero subito dopo, anche per effetto della concessione della Costituzione. Nel giro di poche settimane, tra agosto e settembre, le truppe borboniche stanziate in Calabria si sbandarono, i liberali meridionali presero il controllo delle province e Garibaldi entrò trionfalmente nella capitale. La politica di Cavour e la determinazione dei radicali portarono a conclusione la fase cruciale dell’unificazione nazionale. In realtà la questione del Mezzogiorno non ebbe nulla a che vedere con l’annessione degli Stati dell’Italia centrale o della Lombardia. Non ci fu una transizione pacifica. A settembre, proprio nel momento di maggior successo della rivoluzione, iniziò una poderosa controrivoluzione che durò per anni. Nei primi sei mesi fu l’esercito borbonico il protagonista dell’estrema difesa del regno, dimostrando una inaspettata quanto determinata volontà di combattere. La resistenza all’unificazione si combinò poi con altre due controrivoluzioni: una di origine popolare e un’altra di tipo cattolico legittimista.
La mobilitazione rurale finì per unire resistenza armata e criminalità comune, fu chiamata brigantaggio e durò diversi anni.
Nella fase iniziale guerriglieri, ex militari borbonici, volontari legittimisti europei, nobili, militanti locali si riconobbero nel governo in esilio di Francesco II, tentando una sanguinosa, confusa e inutile riconquista del Regno. A partire dall’autunno del 1861, falliti questi tentativi, la guerriglia accentuò le sue caratteristiche banditesche, fino alla definitiva repressione da parte delle forze di sicurezza italiane. Altrettanto complessa fu la resistenza cattolica.
L’alta gerarchia ecclesiastica meridionale rifiutò radicalmente la rivoluzione unitaria. Il Concordato del 1818 aveva sancito la sua identificazione con la Corona delle Due Sicilie: solo un vescovo (su 89) aderì al nuovo regime. Il contrasto fu frontale, in molti casi portò a scontri, all’abbandono di 54 sedi e caratterizzò l’episcopato meridionale come forza di opposizione reale al nuovo Stato (a differenza di parte del basso clero). L’abolizione del Concordato borbonico e la protesta contro i decreti Mancini furono solo le prime tappe di questa frattura, ma la Chiesa sviluppò progressivamente una originale forza di adattamento al nuovo stato delle cose che darà risultati importanti, evitando una drammatica resa dei conti.
La controrivoluzione borbonica, pertanto, pur strettamente collegata a queste due dimensioni della resistenza al nuovo Stato, sviluppò una sua originale critica che aveva radici nel lungo conflitto civile meridionale e nello scontro decennale tra liberalismo e legittimismo. La sua tradizione, i cui valori principali erano la lealtà alla Monarchia e l’unità del Regno, doveva fare i conti con le idee del nazionalismo italiano (ed europeo), con i concetti della comunione culturale e spirituale di un popolo, l’indipendenza da uno straniero, l’alleanza tra nazione e libertà. I borbonici assunsero una rinnovata identità patriottica quando l’Italia diventò una realtà e iniziavano a consolidarsi i maggiori fenomeni nazionalisti europei.
Fu la guerra del 1860-61 a comporre in maniera conclusiva una rinnovata e originale definizione del patriottismo napoletano. La memoria e la critica si identificarono nel ricordo dell’esperienza dell’estrema difesa del Regno includendo i miti a cui diede origine. Quegli episodi diventarono il cuore delle narrazioni di veterani e scrittori che presero posizione rispetto ad una frattura radicale della loro esperienza di vita, una rottura segnata dalla fine del proprio stato e del proprio ambiente sociale. Questo studio si propone di comprendere se i difensori delle Due Sicilie giunsero a creare una nuova idea della patria napoletana, frutto tanto dei caratteri della crisi finale del regno quanto del definitivo confronto con il nazionalismo unitario italiano, ponendo le basi di una propria tradizione che forse conserva ancora oggi alcuni elementi nel Mezzogiorno e che furono rielaborate in molte delle fasi di crisi del rapporto tra il Sud e il resto del paese.
La premessa di questo problema è lo scontro iniziato alla fine degli anni Novanta del Settecento che contrappose i sostenitori della Rivoluzione ai difensori dei vecchi Stati. Nei decenni successivi il Sud era stato coinvolto dalle due ondate rivoluzionarie europee (1820 e 1848) e da una moltitudine di rivolte, cospirazioni, lotte locali. Nella prima metà del secolo si era consolidata una complessa e variegata tradizione liberale, ma i borbonici vantavano la propria: i lazzari napoletani e l’armata di Ruffo, i guerriglieri del Decennio francese e il principe di Canosa, la classe dirigente di Ferdinando II e i vincitori delle campagne del ’48 in Calabria e Sicilia. Questa realtà ha ricevuto una attenzione marginale negli studi storici e resta in gran parte inesplorata nel campo della ricostruzione delle culture politiche. Nei primi decenni post-unitari la
storiografia si era concentrata prevalentemente sulla prospettiva rivoluzionaria, mettendo al centro della sua analisi prima le fondamenta dell’incontro tra il liberalismo e la scelta unitaria, poi la struttura socio economica e le caratteristiche della borghesia meridionale (con una particolare attenzione alla questione siciliana). i punti di forza delle Due Sicilie, sottolineando il tentativo di modernizzazione dello Stato tentato da Ferdinando II. valorizzano lo sviluppo degli antichi regni nell’età della Restaurazione e mettono in discussione l’assioma della loro inevitabile dissoluzione. Nel 1815, all’interno dello scacchiere geopolitico definito a Vienna, le Due Sicilie si presentavano come la maggiore potenza italiana: molti esponenti della sua classe dirigente (innanzitutto il principe di Canosa) pensavano addirittura ad una espansione nella penisola. La tradizione nazionale, inoltre, non era stata neppure messa in discussione nel Decennio francese (Murat aveva imposto nel 1811 la naturalizzazione napoletana ai funzionari stranieri), né nel successivo quinquennio e neppure durante la rivoluzione liberale del 1820, quando gli stessi militari liberali avevano combattuto per impedire la secessione palermitana (mentre il Parlamento fu unanime nel sostenere le ragioni unitarie dello Stato).
Si tratta quindi di superare definitivamente una visione, che già immediatamente dopo l’Unità si propose un’immagine declassata del Mezzogiorno, cercando invece di comprendere anche il profilo e le ragioni di chi cercò di scongiurare la realizzazione del processo unitario. Il problema della scelta di campo (perché si diventava patriota) e della conseguente formazione di una coscienza nazionale, può essere ribaltato proprio nel campo dei difensori degli antichi Stati, un quesito che riguarda anche la dimensione partecipativa e la visione ideologica di questi uomini. Allo stesso tempo, la scelta di introdurre questa analisi in una fase drammatica, la fine dell’indipendenza del Regno, consente di uscire dalle letture concentrate sugli anni della Restaurazione o dalla ricerca esclusivamente legata alle origini del Risorgimento. Il problema della relazione tra tradizione nazionale mridionale e crisi dello Stato si inserisce inoltre nell’indagine sulle fratture storiche del Regno. La maturazione di un senso di appartenenza e di costruzione istituzionale nei vecchi Stati italiani. Si tratta di ricostruire il profilo politico e l’identità delle élites e dei gruppi impegnati a difenderne l’esistenza e poi a perpetuare la memoria: perché migliaia di napoletani morirono (e molti altri combatterono) per la propria nazione (una domanda che pone anche la necessità di comprendere i termini e le dimensioni della partecipazione legittimista) e con che idee di patria avevano a che fare? Gli scritti dei reduci borbonici sono una delle possibili fonti utili a rispondere a questa domanda proprio perché riferiti a quel cruciale passaggio dove la dissoluzione del regno si incrociava con la nascita della nazione italiana. Lo studio delle loro testimonianze ci consente di analizzare una narrazione dotata di una molteplice costruzione retorica: la creazione di una rinnovata idea di patria (la nazione napoletana) e l’idea di una comunità (l’antica e legittima tradizione del regno); il conflitto con i propri connazionale (la guerra civile) e una epopea collettiva (la difesa dell’indipendenza). In questo modo possiamo chiederci quale rappresentazione i veterani del Sessanta diedero della loro appartenenza nazionale, con la conseguente critica al Risorgimento. La celebrazione di un nazionalismo napoletano che aveva difeso l’indipendenza delle Due Sicilie diventò il momento costitutivo della rinnovata identità borbonica, incarnata innanzitutto dall’esercito: all’inizio del suo libro il capitano Tommaso Cava scrisse che “l’esercito napoletano difese la Nazionale indipendenza”. Cava proveniva da una famiglia di antiche tradizioni militari ed aveva diretto lo stato maggiore borbonico durante l’assedio di Capua. Dopo l’Unità, pur arruolato nell’esercito italiano, ne era stato subito espulso per aver voluto “difendere l’onore” dell’armata delle Due Sicilie. Il suo collega Carlo Corsi, ufficiale di artiglieria a Gaeta e attivissimo organizzatore del reducismo borbonico (aveva anche sfidato l’ex ministro di Francesco II e ora generale italiano, il traditore Pianell), iniziò il suo volume allo stesso modo per “tenere alto il nome napolitano tanto oltraggiato ed avvilito”. Il guerrigliero Teodoro Salzillo, funzionario di Isernia, tra i capi delle temibili formazioni irregolari che avevano fatto strage di garibaldini nel Molise, definì la campagna del 1860- 1861: “la più gloriosa per le Armi Napolitane” proprio perché avevano combattuto per la libertà della patria. Il colonnello dello stato maggiore Giovanni Delli Franci, napoletano, uomo di spicco in tutte le operazioni del 1860, autore di una fortunata Cronaca della campagna d’autunno, ampliava questa tesi: i napoletani lottarono con coraggio per la libertà le Due Sicilie e contro le “corti che ne vollero infranta l’autonomia”. Il capitano Sinibaldo Orlando, molisano, apprezzato comandante di una compagnia di Cacciatori, in prima linea nella campagna del Volturno, sostenne che l’esercito napoletano non avrebbe potuto combattere contro “l’elemento rivoluzionario di tutta Europa e i due eserciti avversi senza lo spirito di cui era informato e di vera nazionalità di cui era in vanto”. Luigi Gaeta, casertano, ufficiale di stato maggiore impegnato nel comando della cittadella durante l’assedio di Messina (e altro importante animatore dell’ambiente dei reduci), scrisse che la “vera gloria nazionale” delle Due Sicilie era l’esercito che “difendeva la propria onorata patria autonomia”. La rivendicazione nazionale si confondeva con l’antico patriottismo rappresentato dall’unione con la Casa reale. Il giuramento, inteso come rituale individuale o collettivo, era la figura simbolica a cui sistematicamente si faceva ricorso per rendere sacra questa comunione tra il re e i difensori della patria. Una sacralità che trasformava il giuramento al sovrano ampliandolo ad un più ampio concetto di nazione. I difensori di Capua affermarono: “intendiamo restare fedeli al nostro giuramento […] gelosi custodi di quell’onor militare”. Il maggiore di artiglieria Pietro Quandel, figlio di un personaggio importante delle gerarchie militari borboniche (famoso nella repressione del brigantaggio filo carbonaro pugliese), combattente a Gaeta e poi esule con la famiglia reale a Roma. Quandel scrisse nel suo resoconto dell’assedio che il comportamento dei militari fu il più autentico esempio di fedeltà: La guarnigione è stata sempre sostenuta dal pensiero di adempiere ad un sacro dovere e mantenere la fede giurata, ed è stata incitata a ben fare dall’esempio che loro han porto le Loro Maestà il Re Francesco II e la Regina Maria Sofia, e le Loro Altezze Reali il Conte di Trani ed il Conte di Caserta, che han condiviso costantemente coi difensori della Piazza pericoli, privazioni, disagi. Il re e la dinastia rappresentavano il legame con il passato del Regno ma simboleggiavano anche la difesa dell’indipendenza. Banti e Ginsborg hanno scritto che l’ibrido rapporto tra una comunità nazionale e una casa regnate è un fenomeno diffuso nel nazionalismo ottocentesco. I proclami pubblicati da Francesco II, in quei mesi drammatici, diventarono i testi sacri della comunità dei veterani. Il capitano Gaeta, come quasi tutti i suoi commilitoni, ricordò quando il re celebrò i soldati che resistendo alle perfide seduzioni, ed agli sforzi delle due armate, (avevano) saputo non solo tenere fermo, ma illustrare ancora la storia dell’armata Napoletana, coi nomi di Santa Maria, Caiazzo, Trifilisco, S. Angelo e altri… Di tale luminose azioni, ne resterà per sempre memoria nel mio cuore, e per perpetuarne la rimembranza, sarà coniata una medaglia di bronzo con l’epigrafe da una parte: Campagna di settembre ed ottobre 1860… Questa medaglia adornando i vostri petti ricorderà a tutti la vostra fedeltà, ed il vostro valore, che saranno sempre un soggetto di gloria per coloro che erediteranno i vostri nomi. Tutti conservarono il commiato del re, letto alla guarnigione di Gaeta nel febbraio del 1861. Molti lo avevano trascritto e lo portavano sempre con sé, anche perché trasmetteva molti principi della nuova identità borbonica: I tradimenti anteriori, l’attacco delle bande rivoluzionarie, l’aggressione di una potenza che si diceva amica, niente à potuto contrastare la vostra bravura, affievolire la vostra costanza… voi avete lasciato sulle rive del Volturno e del Garigliano le tracce del vostro eroismo, e voi avete sfidato per più di tre mesi, in queste mura, gli sforzi di un nemico che dispone di tutte le forze d’Italia… quando i miei più cari soldati rientreranno nelle loro famiglie, tutti gli uomini di onore chineranno il capo al loro passaggio.
La stessa argomentazione valeva per le altre piazzeforti. I difensori di Messina citavano il manifesto del re alla guarnigione che concludeva: “un giorno ciascuno di voi potrà dire con orgoglio: io nel 1860 feci parte dei difensori della cittadella di Messina”. La patria era soprattutto il ricordo della sua estrema difesa. I proclami, le medaglie, simboleggiavano una nuova comunità, per molti aspetti divenuta tale proprio quando era scomparsa. Il re e i compagni sopravvivevano nei ricordi dei veterani trasformando il senso dell’appartenenza napoletana e immortalandola. Il capitano del Genio borbonico Giuseppe Quandel, un altro dei tre fratelli impegnati a fianco di Francesco II (diventerà poi esule ed infine abate di Montecassino), concluse il giornale dell’azione del suo corpo spiegando che il valore di quella resistenza, il senso profondo del legame nazionale, era proprio nella consapevolezza di difendere una causa perduta: laonde mancava, ai morenti napoletani, la dolce speranza di vedere quando che fosse vittoriosa la causa che difesero col loro sangue, e noi mille volte udimmo i nostri commilitoni, presso a I difensori del 1860 venivano almeno confortati dal pensiero che la loro sorte era unita a quella d’invitte e gloriose nazioni, che com’essi combattevano per la libertà che loro levasi togliere, e che il Re riconoscente, ed una terra ospitale, accoglierebbero l’orbata sposa e i figliuoli, darebbero un’onesta esistenza al mutilato. Ma non v’era scampo…i Napoletani di Gaeta non vedevano lor dinnanzi che la servitù, la prigionia, l’ingiusto obbrobrio degli accecati loro concittadini, e forse la morte.
Anche il terzo fratello, Ludovico Quandel, era un ufficiale di artiglieria che finita la campagna del Volturno aveva raggiunto Gaeta. Nel suo ricordo, la morte della patria coincideva con la resa finale. Quandel era tra i graduati in testa alla colonna che uscì dalla fortezza per accogliere l’onore delle armi degli assedianti piemontesi, prima di consegnarsi al nemico: l’ordine di marciare è dato, e man mano i Corpi cominciano il loro movimento prima di uscire dalla piazza. È questo l’ultimo atto della monarchia e dell’Esercito delle Due Sicilie: fra pochi minuti l’uno e l’altro passeranno nel dominio della storia.
I reduci del 1860 si erano formati nel lungo e solido regno di Ferdinando II. Ora facevano i conti con la propria esperienza di vita, con il proprio passato, con la loro giovinezza e una antica scelta di campo personale e familiare. Nel 1848 e negli anni successivi ampi settori della società meridionale erano fortemente ancorati all’idea dell’autonomia dello Stato, impersonata dal sovrano che aveva accompagnato la loro carriera politica e militare.
Ferdinando II, ricordò Ruggero Moscati, “napoletano, egli sentiva la ‘nazione napoletana’, non la nazione italiana”. La Seconda Restaurazione aveva trionfato per la determinazione del re, dell’esercito e dei sostenitori del legittimismo. Nel 1849 il Regno delle Due Sicilie non aveva chiesto né voluto l’intervento delle armate straniere per sconfiggere la rivoluzione, rivendicando una legittimazione nazionale nei confronti della svolta autoritaria e legittimista, testimoniata dal folto gruppo di scrittori che esaltarono il re e il suo Stato anche come il più solido baluardo della religione cattolica.
I veterani, ricorrevano quindi a materiali e a simboli del passato per costruire una propria tradizione patriottica, il discorso si innestò sull’azione di coloro che avevano difeso il vecchio Stato fino all’alba del suo crollo. La nazione era un’eredità che si spingeva sul richiamo alle generazioni precedenti, tutti i reduci sottolineavano le proprie storie familiari di lealtà alla Corona e al Regno. Le argomentazioni non contenevano rivendicazioni etniche o linguistiche, si basavano sull’accusa della subordinazione del Mezzogiorno unitario agli stranieri piemontesi, della fine del controllo sulle istituzioni e sulla propria economia da parte dei napoletani, della svendita o della rapina delle sue fortune e bellezze. Denunciavano il degrado, scriveva Delli Franci, di uno “stato ricco e felice” o, aggiungeva l’ex funzionario, saggista ed esule Giacinto De Sivo, difendevano “la nazione nostra sfatata, noi pinti al mondo quasi barbari”. I borbonici valorizzarono le ragioni di una comunità antica che difendeva da sempre la propria indipendenza, per esempio sostenendo con successo una resistenza vittoriosa contro gli invasori francesi. Spesso questo si trasfigurava in un passato glorioso e puro: il ricordo del 1799 mitizzava l’opposizione popolare del Regno dalle invasioni straniere. Luigi Mira, dirigente del Ministero di Polizia in esilio a Roma, che guardava con sospetto la guerriglia e il brigantaggio, ricordò che l’emigrazione napoletana sognava “un nuovo Cardinal Ruffo”. Corsi scriveva che i lazzari napoletani nel 1799, sforniti di armi e di artiglierie, e con Sant’Elmo che sparava alle loro spalle, tennero fermo per 3 giorni alle vittoriose schiere dei francesi guidate dallo Championnet, e se non fossero stati traditi, i francesi avrebbero dovuto decampare. Una vicenda che la storia aveva dovuto scrivere a caratteri d’oro.
Francesco Scamaccia Luvarà, intellettuale e avvocato napoletano, tra i leader del movimento legittimista post-unitario, riannodava le fila di questo passato collegando la resistenza del 1799 a quella del Decennio francese, la gloriosa epopea di Ruffo “di nobile prosapia e ardimentoso” con la difesa di Maratea o di Amantea e le rivolte del 1806-1808, quando in tutte le province grandi masse “si levarono in armi, e fervevano quei popoli” contro gli invasori e la loro quinta colonna napoletana. Il ritorno del re, diceva lo stesso autore, aveva restituito “libera la patria” nel 1815.
Una memoria storica alternativa a quella che i liberali stavano trasformando nel piedistallo monumentale dello Stato nazione.
Dopo il 1861 l’esercito aveva testimoniato la forza e la vitalità dell’idea della vecchia patria. Nel 1848, ribadiva Corsi, l’armata mostrò che le Due Sicilie potevano sopravvivere alla tempesta rivoluzionaria con le proprie forze “facendo ritornare la Sicilia all’obbedienza del proprio sovrano”. L’esercito era depositario del patriottismo napoletano, dopo aver sostituito i nostalgici napoleonici ammutinati nel 1820 (che pure avevano difeso in Sicilia e in Abruzzo il Regno). Gli uomini del 1860 erano i giovani del 1848, avevano interiorizzato il problema dell’autodeterminazione nazionale nello scontro con i liberali. Oltre all’autodeterminazione, l’altro punto centrale della riflessione di questa generazione era l’unità dello stato, spiegò Cava, che qualche mese appena, dopo che il Generale Filangieri nel 1849 riconquistò la Sicilia; l’ordine e la sicurezza pubblica ritornarono come d’incanto in tutta l’isola, tuttoché essa aveva sofferto 16 mesi di anarchia”. Il passato aveva offerto anche i modelli concreti ai combattenti del 1860: “i soldati napoletani erano a fronte del nemico per non ismentire la loro fama e quella rinomanza antica, fatta più splendida nelle dolorose vicende del 1848”.
I difensori di Messina, per esempio si ispirarono ai loro predecessori del 1848 che, ricordava nel suo diario il capitano Gaeta quando “la cittadella… ad onta ch’era ridotto ad una ammasso di rovine, resisté sempre fino al termine dell’assedio”. Il 1848 dei liberali era rovesciato!. Il 15 maggio monumentalizzato da questi era per i reduci solo una vergognosa gazzarra, dove c’erano “barricate non erette dai napoletani, ma da provinciali e siciliani accorsi in Napoli”, che le truppe avevano saputo facilmente e rapidamente sgominare. Delli Franci, ricostruendo tutta la storia delle armi napoletane, sostenne che l’esercito di Ferdinando II aveva mostrato disciplina, senso del dovere e la capacità di difendere “il potere legale minacciato”. Il colonnello borbonico ricostruiva poi le tappe dell’impegno bellico (1793-1794, 1799, 1806- 1814) per confermare le tradizioni patriottiche e legittimiste dell’esercito napoletano.
Il 1848 aveva solo confermato che la patria si identificava con chi ne difendeva autonomia e tradizioni. Al contrario, ogni concessione al nemico ne aveva provocato lo sgretolamento. Lo storico Cesare Morisani, intellettuale calabrese influente nella sua regione, affermò che “la costituzione cacciò dal potere gli uomini devoti alla dinastia, per farli sostituire da quelli, che avevano lavorato, e aspiravano al trionfo della rivoluzione”. Filippo Pisacane, aristocratico napoletano e colonnello di cavalleria, (fratello del più famoso Carlo), in esilio con la famiglia reale fino alla sua morte, sostenne che fu la scelta della costituzione a determinare il crollo del Regno: la penna rifugge a dettagliare la serie dei fatti compiutisi, sotto il manto della più vile ipocrisia per cadere il Re nel laccio di concedere Franchigia al Popolo, appunto nelle circostanze in cui un governo che ne fosse stato in pieno possesso sarebbe stato nel dovere di sospenderla, e ciò sotto la pressione delle due precisate Potenze i cui rappresentanti erano i più forti sostegni del Piemonte.
Uno dei pochi liberali che avevano seguito Francesco II, Pietro Calà Ullòa, membro di una delle più antiche famiglie napoletane, intellettuale e magistrato di primo piano, oltre che capo del governo borbonico in esilio, pur difendendo la scelta costituzionale, non poteva che confermare questo dato. Appena iniziò il brigantaggio nelle province meridionali tra gli esuli a Roma “rinacquero le speranze e molti improvvisati costituzionalisti si rivelarono, quali erano, arrabbiati ultrà” “quella gloriosa e sventurata campagna del 1860 1861”, così definita dal generale borbonico Giosuè Ritucci, generale napoletano, comandante del fronte del Volturno e memoria storica dell’armata delle Due Sicilie. “Una grande epica” collettiva che immortalava l’esistenza di questa nazione e la volontà di resistenza dei napoletani, offrendo ai reduci una serie di immagini e di temi efficaci nel delineare identità e coscienza di sé: il disprezzo per la prepotenza dello straniero, il tradimento, l’appello del re, gli eroi, i soldati popolani ed altri concetti che evocavano i valori patriottici ma spesso finivano per avvicinarsi alla morfologia del discorso unitario italiano. Lealtà e resistenza erano i punti di partenza insostituibili di questa narrazione. Una campagna molto più epica rispetto a quelle del 1806 o del 1821 (dove i principali sostenitori della dinastia erano stati gli alleati stranieri), che aveva ritrovato una comunità in lotta per il riscatto della patria. Migliaia di militari sbandati o abbandonati dai capi in Calabria e in Puglia avevano raggiunto a prezzo di immensi sacrifici i resti dell’esercito. Lo storico calabrese Morisani scriveva che “i soldati erano accanitamente partigiani del Re… quando traditi, dovettero cedere le loro armi senza combattere, attraverso mille pericoli, raggiunsero le loro bandiere”. Il colonnello Delli Franci esaltò l’inflessibile volontà di difendere il Regno riscoperta sul Volturno. Questi argomenti nella narrazione borbonica rivestirono una potente variante identitaria unendosi al sentimento di un profondo cameratismo dei difensori della patria napoletana. Nella memoria di tutti i militari borbonici, la bandiera e l’inno nazionale (quello scritto da Paisiello) avevano entusiasmato ed unificato gli sbandati che avevano ricostruito l’esercito sul Volturno, dopo le umiliazioni dei mesi precedenti. Il capitano Corsi, scriveva che i veri combattenti napoletani erano quelli che avevano risposto a “questo nobile appello… in pochi giorni l’amato Sovrano fu circondato da 49 mila uomini, bravi, fedeli e decisi a morire per esso”. Questo momento era indelebile e rievocato da tutti. Cava ricordò che quasi tutti i corpi sbandati, vennero volontariamente a raggranellarsi dietro il Volturno, ed era commovente vedere come quei soldati, laceri, scalzi, defatigati pel lungo cammino fatto, affin di schivare i luoghi occupati dall’oste garibaldina, animavansi appena giunti in mezzo ai loro compagni; ed esclamando Viva il Re chiedevano un’arme con cui combattere.
Gaeta si commuoveva al ricordo dell’esercito assediato a Messina che officiava la festa della Vergine di Piedigrotta e l’onomastico della regina. L’intera guarnigione, abbandonata anche da quelle di Siracusa e di Augusta, celebrava orgogliosa la sua resistenza estrema: “La piccola parata riesce magnifica. L’entusiasmo è generale quando dalla truppa schierata in battaglia, al presentate le armi, dopo il suono dell’Inno Reale si eco il grido Viva il Re pronunziato dal Generale. È un triplice scoppio di gioia e della più sentita devozione verso l’amato Sovrano”.
La comunicazione simbolica andava ben oltre questa testimonianza e faceva perno su una riserva di materiali che erano tipici dei movimenti nazionalisti del XIX secolo. Il capopopolo Salzillo dedicò il suo libro ai fedelissimi borbonici che aveva conosciuto a Gaeta e che “teneste, fino all’estremo, atto lo squarciato lembo della Bandiera del Re, simbolo dell’indipendenza della Patria comune”. Morisani scriveva che “giammai il regno di Napoli ricorda soldati così fedeli alla bandiera”. Il ricorso a strumenti retorici non riguardava solo il giuramento e la bandiera: esaltava il tema della fedeltà alla patria e al suo rappresentante simbolico (il re) e di converso il problema dell’invasione straniera.
La resistenza di Gaeta concentrava tutti questi miti: il sangue e la dinastia, la regina sugli spalti e l’aggressione straniera, l’esercito di popolani e la comunità assediata. La regina tedesca fu al centro di molteplici narrazioni già nei giorni dell’assedio: testi, canti, commedie (e terribili accuse dei nemici). Il suo profilo offriva una risorsa simbolica invidiabile: giovane e bella, coraggiosa e determinata, ferma sugli spalti di Gaeta, incarnò una delle più epiche immagini della difesa della patria. Angelo Insogna, intellettuale legittimista napoletano, raccontò che “La presenza sua sopra i bastioni aumentava il coraggio dei soldati e rianimava, nel cuore di questi diseredati della fortuna, la fiducia e le forze”.
La fortezza assediata si prestava ad un racconto potente: l’estrema resistenza nell’ultimo lembo della patria. I suoi difensori, scriveva il maggiore Quandel nonostante la superiorità dei mezzi, onde han potuto disporre i piemontesi…in tutta la durata della difesa lo spirito militare della guarnigione è stato commendevolissimo. Non la scarsezza della paga e della razione dei viveri, non la deficienza delle vestimenta, non gli incessanti e sempre crescenti disagi, non i faticosi lavori, non le malattie e soprattutto quelle gravissime del tifo, non le perdite ed i pericoli quotidiani ne hanno abbattuto un sol momento l’energia .
“Gaeta fu difesa d’onore, protesta di sangue all’invasione, non altro”, scrisse Morisani. La patria era stata difesa con il sangue napoletano. Il calabrese riprendeva i temi del nazionalismo europeo quando scriveva che “quei soldati.. traditi, soffrendo la calunnia, l’ingiuria, la fame…sono giunti sfidando mille pericoli, a valicare il Volturno, a rifornirsi d’un’arma per protestare col loro sangue dell’ingiuria patita”.
La scelta di campo in condizioni disperate era quindi il mito unificante della resistenza borbonica. Un atto che valeva anche per i popolani analfabeti che avevano combattuto (ma non sapevano raccontarlo). Giuseppe Buttà, siciliano, cappellano militare dei Cacciatori borbonici, aveva partecipato a tutti gli scontri della campagna (diventò, tornato dall’esilio a Roma, un pubblicista di successo nel mondo legittimista napoletano). Nei suoi scritti esaltò coloro che nei paesi si erano sollevati contro il plebiscito (definito da Insogna, ad esempio, una “commedia italiana”) .
Questi uomini, demonizzati dalla pubblicistica liberale, erano l’autentico popolo napoletano che i piemontesi avevano represso “a furia di terrore e di vandalici espedienti”. Scamaccia Luvarà spiegava che i nemici stranieri, francesi o piemontesi, chiamavano sempre briganti “i partigiani del caduto dominio”.
Nella rielaborazione della memoria erano però le scelte individuali ad avere un posto d’eccezione: era l’eroe, disposto a sacrificare la propria carriera o la vita in queste circostanze straordinarie. Le prese di posizione dei singoli erano la prova della fedeltà alla patria napoletana e del tradimento dei corrotti. Il comandante della Piazza di Messina, Fergola, raccontò il suo capo di stato maggiore Gaeta, respinse le continue offerte e lusinghe di inviati diplomatici e cavouriani, anzi stigmatizzò la resa del generale Locascio a Siracusa. “Preso quindi da indicibile orrore in sentire l’esecrando procedimento di un intelligente ed antico ufficiale come lei”.
L’esilio era un altro luogo simbolico che i borbonici condividevano con i liberali nel sacralizzare le scelte individuali. Il vero patriota lasciava la patria occupata. Calà Ullòa, nelle sue memorie ricorda i colloqui con il re, rivendicando di aver scelto l’esilio “per devozione a V. M. non solo, ma al bene della patria e all’onor mio”. Patria e onore erano alla base di una scelta personale. Il capitano Ludovico Quandel scrisse che lui ed altri giovani ufficiali, sbandati nel Lazio e decisi a raggiungere Gaeta, erano stati consigliati di entrare subito nell’esercito italiano, ma avevano replicato all’interlocutore (l’abate di Monte Cassino) che non potevano “abbracciare una altra causa mentre a Gaeta e in altri punti del Regno sventola ancora la bandiera dell’Esercito napoletano”.
L’eroismo andava ben oltre il problema della carriera e puntava direttamente alla retorica del sangue versato per l’indipendenza della patria. Anche in questo caso condividendo un tema proprio dei nazionalisti italiani, analizzato per ultimo da Lucy Riall.
Nei giorni di settembre, ad esempio, un gruppo di giovanissimi allievi della Nunziatella (avevano tra gli 11 e i 17 anni) riuscirono a fuggire da Napoli e a raggiungere l’esercito del re combattendo fino a Gaeta. I giovanissimi che parteciparono all’ultima e disperata difesa diventarono un altro mito della nazione borbonica. Il nucleo profondo della sacralizzazione della vecchia patria era la celebrazione dell’estremo sacrificio, il momento più alto nella definizione di una gerarchia di dedizione e, anche, di dolore. Giuseppe Quandel citò l’ordine del giorno del suo superiore, il generale Traversa, che elogiava i subordinati in linea per la difesa del “nostro valoroso e magnanimo Sovrano e dalla Patria Napoletana” letto poco prima di essere ucciso. Il capitano Orlando rammentava un cacciatore “che ferito gravemente un’ora prima, dopo di essersi fasciato si riconduceva al suo posto reggendosi in piedi a stento”. Raccontò di averlo abbracciato tra la commozione e le grida della sua compagnia. Questi aneddoti riempivano la sua narrazione (e quella di tutti i veterani): il colonnello Capecelatro, ferito sul Volturno, gridava Viva il re mentre veniva portato gravemente ferito nelle retrovie.
Il caso più famoso era quello di Matteo Negri, il giovane colonnello considerato un po’ il coraggioso Ettore dell’esercito napoletano: era citato da tutti, dopo che fu ucciso in combattimento dai piemontesi: “spirando la bell’anima dopo brevissimo tratto, recando così una irreparabile perdita all’esercito”. Un altro eroe era l’erede dei de Sangro, una delle grandi famiglie napoletane. Il capitano Pietro Quandel raccontava che “il valoroso e modesto Tenente colonnello De Sangro del Genio” era caduto “mentre dirigeva i lavori alla breccia”,con l’esplosione di tutta la sua batteria a Gaeta.
La morte di un figlio era poi l’episodio simbolicamente più intenso. Ludovico Quandel, descrivendo l’assalto sul Volturno, ricordò che in quel combattimento noi perdemmo un gran numero di soldati e molti ufficiali esteri fra i quali lo stesso figlio del Generale Von Mechel, che all’annunzio della morte gloriosa del figlio, toltosi dal capo il kepì gridò ai suoi soldati: “vive le Roy en avant” e continuò a combattere. Per i borbonici, non c’era una rivoluzione, ma una conquista straniera, materialmente realizzata dai piemontesi spergiuri e concretamente favorita dalla quinta colonna napoletana. I nemici esterni erano i settentrionali denunciati nel proclama di Francesco II: “una colonna di truppe piemontesi, calpestando i sacri diritti delle genti, ed i sentimenti di giustizia, à osato senza nessuna dichiarazione di guerra, invadere il regno”.
Si trattava degli invasori che poi avevano depauperato il Regno: “noi napoletani i piemontesi trattarono quasi come popoli conquistati, distruggendo tutto ciò che v’era di buono senza nulla creare, e col concorso degli emigrati, che inesorabili vi prestarono la mano”.
Il conflitto civile era un tema ben più complesso e drammatico: creava la connessione tra il nemico interno ed il nemico esterno e, allo stesso tempo, individuava le responsabilità dei liberali napoletani e siciliani. La fine del Regno aveva esasperato i contrasti tra i meridionali, spezzando l’agognata coesione sociale e culturale a cui aspiravano i borbonici. Anzi, i rivoluzionari erano la negazione di quella nazione unita e sognata, uno dei principali problemi della memoria duosiciliana. Questo elemento non poteva essere negato né restare implicito, dopo che tutti i veterani avevano visto ovunque meridionali combattere contro l’esercito napoletano. La guerra civile tanto ripudiata da Mazzini, da Poerio o da Berchet era un abominio anche per i borbonici. Per il capitano Orlando il re aveva deciso di lasciare Napoli proprio per evitare “di esporre la nostra bella e grandiosa Napoli agli orrori di una guerra civile”. Il colonnello Delli Franci raccontava di aver visto: con dolore famiglie opposte in due opposti partiti, per combattere l’uno contro l’altro, entrambi per un principio nazionale diverso tra loro. Da un canto soldati, che fedeli alla religione del giuramento dato al Re ed alla patria, difendevano il trono minacciato e con esso la costituzione del paese; dall’altro cittadini armati, aiutati da militari spergiuri e d’avventurieri d’ogni paese, tra i quali erano soldati piemontesi vestiti alla garibaldesca, che seguaci di altr’ordine politico di maggior’ estensione, facevano guerra al legittimo Signore ed alle patrie istituzioni, per essere governati d’altra dominazione.
Occorreva però fare i conti direttamente con il nemico meridionale: questo aveva causato la dissoluzione della patria e contaminato il sogno di una compatta comunità nazionale. La figura dell’avversario interno (quinta colonna o traditore) aveva una posizione centrale nella narrazione borbonica. Scamaccia Luvarà scriveva che da più di sessant’anni, dal 1794, i traditori erano appartati in “segreti concilii […] parteggiando arditi ai danni della patria”. Per l’avvocato legittimista, questa relazione tra i rivoluzionari e il nemico straniero era antica: “Come fu poi per il Piemonte, la Francia ladra e audace quella che soffiava nella nuova discordia: ed erano strumenti della sua avidità, “come i martiri sessantisti”, allor ai fuoriusciti che tenvansi Oltr’alpi, così precisamente che quest’altri malvagi barattieri a Torino della propria patria”.
Questa descrizione si trasfigurava a volte nell’immagine di un traumatico isolamento. Uno degli assediati di Messina ricordava con sdegno quando a Siracusa i commilitoni li avevano abbandonati, avendo “fraternizzata l’intera guarnigione coi pagani, ed installata la Guardia Nazionale”. Il cappellano Buttà descriveva il disprezzo che a volte i soldati con la divisa borbonica incontravano tra i civili dello stesso Regno: quando la truppa giunse a Messina, gli abitanti di questa città ci guardavano come se fossimo gente da nulla…I fatti di Palermo avevano tolto a questo Governo la forza morale tanto necessaria a reggere i popoli. I Messinesi non avevano difficoltà di dirci altamente quello che pensavano de’ soldati e del Re.
Il colonnello Giuseppe Ruiz de Ballestreros, siciliano, un comandante di brigata che restò sempre fedele al re e dovette difendersi dalle molte critiche per i suoi insuccessi militari, descriveva il clima che spesso traumatizzava i comandi borbonici in alcuni territori del Regno. Nel suo libro ricorda la campagna calabrese.
In quei giorni lui e la sua brigata, scrive, furono trattati dagli abitanti quasi come una massa di appestati. Il colonnello si era sentito un estraneo tra i suoi concittadini. Anche se non era sempre così: al contrario, nel casertano e in Molise era successo l’opposto. La narrazione borbonica era intrisa di queste contraddizioni, la guerra civile per i più disincantati, era la percezione di una drammatica crisi interna alla società meridionale, che, scriveva il generale Ritucci, aveva “le radici della zizzania disseminata dalla rivoluzione (che) si erano bene propagate sotterra”. Il nemico interno per Orlando era composto da “quei rinnegati del napoletano, così detti martiri della Santa Causa, che per spirito di parte, fin dal primo esordio della rivoluzione, […] associati stoltamente al perfido disegno di altri inqualificabile ambiziosi cospiratori piemontesi”.
Alla base del successo di Garibaldi, c’era l’azione occulta di Cavour. Ma si trattava, ribadivano ad ogni passo, di una politica favorita da molti meridionali che attraverso le sue reti di corruzione politica ed economica avevano: raggiunto il nefando scopo di spargere in questo Esercito la diffidenza, nata dal vedersi tradito da tanti capi, la cui mano onnipossente di Dio, condanna oggi a portar bassa la fronte… Sapeva il Garibaldi che poco o nulla scienza militare abbisognargli perché i Cavour, i Villamarina, i Liborio Romano, i Nunzianti, i Pianelli, formavano per lui i piani di attacco o di difesa.
Insomma, per quanto fossero importanti le trame internazionali, erano innanzitutto i liberali meridionali che avevano venduto il Regno, la quinta colonna dei piemontesi invasori. Corsi sostenne che “i negoziatori del turpe mercato furono quei nostri fuoriusciti, i quali nel 1848, dopo aver insanguinato Napoli, ripararono a Torino, ove con la complicità del Cavour e protetti dalla Francia, e dall’Inghilterra corruppero i loro fratelli, sia con l’oro, sia con lusinghiere promesse”.
In ogni narrazione nazionale tra le figure del nemico quella del traditore ricopriva un ruolo cruciale. Nel discorso borbonico era intensamente presente, incontrava una fortuna eccezionale per la notevole quantità di politici, militari, marinai che passarono con gli unitari. I traditori, avevano dato la pugnalata alle spalle e consentito la vittoria dei nemici interni ed esterni, ma anche offerto ai leali ed ai fedeli le motivazioni ad agire, a riscattare l’onore della patria. In una crisi morale come quella che aveva travolto le Due Sicilie, il mito del tradimento occupava quindi il primo posto. Il capitano dei Cacciatori Orlando lo definiva un prova per traditi e traditori: Per quanto più possa risultare vergognoso ed infamante la condotta di coloro che si vendettero, disertarono, o tradirono, altrettanto pregevole e gloriosa deve ritenersi quella […] maggior porzione dell’esercito che seppe compiere il proprio dovere.
Gli ufficiali e i politici borbonici che si schierarono con la rivoluzione erano la prova inconfutabile e la giustificazione profonda, per i veterani, della sconfitta. Allo stesso tempo infondevano vergogna ed indignazione, gettavano ombre profonde sul patriottismo e sulla vecchia nazione, mostravano quanto fosse incrinata la sua unità morale. Il risentimento e il disprezzo verso i commilitoni che avevano cambiato bandiera in quei due anni drammatici era forte come la convinzione che il loro tradimento avesse contribuito in maniera decisiva alla fine delle Due Sicilie.
Scrivo finalmente, per coloro, i quali in un momento di oblio tradirono il loro Re, disertarono la loro bandiere e, rivolgendo le armi contro i propri compagni, insozzarono odiosamente quella divisa militare che è il simbolo dell’onore e della fede. Il capitano Cava sosteneva che se il generale Landi fosse stato fucilato alla presenza della sua brigata, per come meritava, or non scriverei di certo queste dolorose memorie, dapoiché i Nunziante, i Pianelli, i Lanza, i Ghio, i Briganti, i Flores e tutta la miriade dei felloni che […]
occultamente o apertamente manovrarono in favore della rivoluzione e della invasione piemontese, non erano uomini da sfidare dodici palle di piombo nello stomaco per favoreggiare le trame del Piemonte e degli emigrati siciliani e napoletani, qualunque fosse stato il prezzo che si sarebbe offerto in compenso.
Alcuni personaggi diventarono l’archetipo del traditore oltre all’intera marina ove “gli uffiziali erano quasi tutti compromessi col ministro piemontese”.
Per il cappellano militare Buttà erano Lanza, Clary, Nunziante, Pianelli e l’avvocatuccio D. Liborio Romano: questi cinque uomini, chi più chi meno, tutti erano stati elevati troppo in alto dai Borboni, e si disobbligarono col tradimento più inqualificabile. Questi cinque uomini sono gli stessi che nel corso di questo Viaggio ho chiamato fatali alla Dinastia e al Regno, che fecero di tutto per farli cadere inonorati, anzi farli rotolare nel fango.
Il traditore finiva spesso per essere ripudiato da tutti, come era il caso del comandante del corpo calabrese Ghio che “né garibaldini, né piemontesi hanno accettato nelle loro fila, altro premio non ha ottenuto, che dagli avversari il disprezzo, dai suoi compagni la maledizione”.
Il tradimento diventava una frattura dolorosa ed insuperabile quando divideva le famiglie ma, allo stesso tempo, esaltava il mito positivo dell’eroe fedele alla patria che cancellava quest’onta e riscattava il proprio sangue e la nazione. Questi esempi contrastanti, dal fratello di Nunziante a quello di Pisacane, diventarono elementi permanenti della narrazione. Uno dei casi più celebri nella retorica borbonica fu quello del primo ufficiale di Marina a passare con i rivoluzionari, il comandante di una pirofregata, Amilcare Anguissola (a lungo celebrato nella mitologia dell’impresa dei Mille perché ebbe un ruolo decisivo a Milazzo e fu poi al Dicastero della Marina nel governo della Dittatura). I due fratelli, Cesare e Giovanni (alti ufficiali dell’esercito), inviarono il giorno dopo una lettera in cui, al disprezzo per il gesto, unirono la richiesta di partecipare come soldati semplici alla campagna siciliana in corso, per “cancellare, in parte la macchia imperitura sul nostro Casato, che incontaminato il vecchio padre ci lasciava in retaggio”. Per i reduci come Corsi queste parole cancellavano la colpa originale dell’infame traditore ed erano “espressione verace del cuore di un soldato di onore” e di fedeltà autentica alla vecchia patria. Invece la scelta del disertore era la prova della corruzione: per il capitano Gaeta ricordava che non si era creduto possibile “sì nero tradimento, tanta infamia”. Anche per lui virtù del fratello “rende più fosca l’infamia del disertore”.
Corsi invece citava la dilagante arroganza dei liberali: “in Napoli funzionavano alla svelata, senza tema di essere turbati, due comitati rivoluzionari, l’uno detto d’Ordine e l’altro detto d’Azione” mentre gli apparati dello Stato stavano a guardare.
La crisi non era spiegabile solo con la penetrazione degli avversari nelle istituzioni dello Stato. C’erano gelosie, fragilità, corruzione, insicurezza, una profonda rovina che non poteva essere cancellata in questo processo di rinnovamento identitario. Al colonnello Bosco era stata affidata la difesa di Milazzo, portando una colonna sull’istmo che si apriva sulla fortezza. Eppure, ricorda Gaeta, il generale Clary (comandante della Piazza di Messina) gli aveva raccomandato soprattutto di evitare “la suscettibilità che potrebbero nascere dall’antichità di grado e partecipando al Comandante la Piazza quella parte delle sue operazioni che crederà potergli comunicare”. Mentre Bosco si batteva a Milazzo, la guarnigione della fortezza e il grosso delle truppe restate a Messina non si erano mosse. Non erano traditori in questo caso (Clary resterà sempre a fianco di Francesco II) ma gelosi ed incapaci. Il capitano Quandel disse: “dolorosi fatti di indisciplina avvengono alla mia presenza fra Ufficiali che trascinati da sentimenti politici, dimenticano i loro doveri di soldati”. Anche gli ultimi giorni mostrarono la degenerazione dei rapporti interni al mondo borbonico. Ludovico Quandel descrisse le assurde manovre ordinate alla sua batteria verso la frontiera pontifica e ricordò come, con altri giovani ufficiali, si interrogava “sulla dappocaggine dei nostri capi”.
Gaeta testimoniò con amarezza e stupore che il comandante dell’artiglieria fosse stato sostituito pochi giorni prima della caduta della cittadella di Messina, “per la vergogna e l’esempio pe’ beneficiati”, insomma per dare un’ultima promozione. Il capitano Cava menzionava gli avanzamenti clientelari di ufficiali ignoranti e impreparati, la divisione dell’esercito in gruppi e sottogruppi, oltre all’eterna ostilità e separazione tra ufficiali di Marina e quelli dell’Armata, l’assoluta mancanza di leadership e di esperienza sul campo tra molti alti ufficiali e il loro tradizionale opportunismo.

“Napoli è la più misteriosa città d’Europa, è la sola città del mondo antico che non sia perita come Ilio, come Ninive, come Babilonia. È la sola città del mondo che non è affondata nell’immane naufragio della civiltà antica. Napoli è una Pompei che non è stata mai sepolta. Non è una città: è un mondo. Il mondo antico, precristiano, rimasto intatto alla superficie del mondo moderno. Napoli è l’altra Europa.
Con queste parole Curzio Malaparte descrive la singolarità della città di Napoli nel suo libro “La pelle“.
Kurt Erich Suckert, letterato e giornalista, per metà toscano e metà tedesco, è stato uno degli scrittori italiani del Novecento più letti in Europa. Animato da una spiccata voglia di contraddizione, scelse come suo pseudonimo Malaparte per contrapporsi con ironia alla grandiosità di Napoleone Bonaparte.
La Pelle mostra il dolore della città partenopea in uno dei suoi momenti storici più difficili: il processo di liberazione del Sud d’Italia dai Nazifascisti. Gli eserciti alleati entrarono a Napoli nell’ottobre 1943 come liberatori, ma le aspettative furono presto tradite. Diffusero per la città una peste, che non dilagava tra i corpi, ma tra le anime dei napoletani. Una malattia sociale che costringeva donne e uomini napoletani a subire atroci malvagità da coloro che li avrebbero dovuti rendere liberi. La peste era nella mano pietosa e fraterna dei liberatori: soccorritori e oppressori allo stesso tempo. Salvatori che abusavano di chi avrebbero dovuto liberare, con la credenza e la giustificazione che un vincitore può tutto su un vinto.
Napoli viene rappresentata in La Pelle come un teatro di morte e i napoletani come “un popolo distrutto”, che si muoveva tra l’accettazione della sconfitta e la felicità apparente della liberazione. Una città accecata dalla sofferenza e pronta a tutto per la sopravvivenza.
Ma questa rappresentazione cruda del capoluogo partenopeo e degli abusi che in esso avevano luogo è costata cara al capolavoro di Curzio Malaparte. Nel 1950, infatti, fu messo all’Indice dei libri proibiti dal Vaticano e riabilitato solo nel 1998.
Senza alcun dubbio una lettura poco attenta del testo fa emergere un’immagine della città di Napoli denigrante e umiliante, complice la brutalità di molti temi evocati, ma il senso più profondo è diametralmente opposto a ciò per cui è stato condannato. Curzio Malaparte voleva mostrare come il valore umano dei vinti, i napoletani, fosse superiore a quello dei vincitori, i liberatori-oppressori. Una contrapposizione capovolta tra vincitori e vinti: chi è stato sconfitto ha conservato la propria umanità, chi ha trionfato si è macchiato di atroci reati.
Consequenziale è la domanda che il romanzo evoca nei lettori: chi sono i veri vincitori? Curzio Malaparte, come Pier Paolo Pasolini con la sua celebre domanda “Qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o battere i cuori?”, fa riflettere il suo destinatario su cosa sia giusto, oltre le apparenti convenzioni sociali, che ci portano a vedere in una posizione di vantaggio chi commette azioni ignobili. Ciò che dunque ne deriva è un elogio del popolo partenopeo non compreso, ma anzi oscurato per 48 anni.
Pochi romanzi, hanno rappresentato con tanta forza l’identità e il dolore di una città, in uno dei momenti più difficili della sua storia. Il romanzo racconta un incontro fondamentale per la storia italiana: quello tra gli Alleati sbarcati a Napoli durante il processo di liberazione del Sud d’Italia dai Nazifascisti e il popolo napoletano. Malaparte, ufficiale di collegamento presso il Comando americano, incaricato di tenere i contatti con la popolazione locale, nato a Prato, in Toscana, ma napoletano nell’anima, tesse un dolente e partecipe atto d’amore alla città, costruendo un potente affresco di questo incontro tra diversi, tra altri, con una scrittura lucida e spietata eppure emozionalmente coinvolta.
Il suo sguardo, in un misto di ferocia che nulla nasconde e di pietà che tutto comprende, fa di questa epopea del dolore e della perdita di sé il più incisivo atto d’accusa contro una “post-liberazione”, sentita dai Napoletani spesso come un’occupazione, divenuta trappola di pregiudizi e inganni, che stringe in una morsa vincitori e vinti. In un’Italia ancora distrutta dalla guerra nel corpo e nell’anima, che solo in parte aveva ricostruito la sua identità nel suo contributo alla Resistenza, disegna a forti tinte il tracciato di una Napoli tragica, facendone un emblema assoluto, non tanto degli orrori della guerra, quanto degli orrori del dopoguerra. Quella stessa città che durante la lotta contro il Nazifascismo si era trovata compatta e eroica di fronte al nemico, quel nemico da cui si era liberata, prima dell’arrivo degli Alleati, con una ribellione strenua e coraggiosa in cui persino i bambini avevano fatto la loro parte. Ma ora al contatto col liberatore si degrada, per salvare a tutti i costi, non più dalla morte ma dalla miseria, quella pelle di cui si parla nel titolo del romanzo. La dignità che paradossalmente era stata conservata, sia sotto la dominazione tedesca che sotto le bombe degli americani non ancora liberatori, diventa difficile da salvaguardare quando i liberatori camminano per le strade della città e sotto il loro sguardo bisogna vivere e sopravvivere, costruendo un’immagine che sia per loro riconoscibile, quella di un vinto che si muove tra accettazione della sconfitta e riconoscenza.
La pelle fu fin dal principio un testo molto controverso e per lungo tempo, interpretato attraverso un’ottica ideologica limitata e limitante che non ne ha saputo cogliere lo straordinario valore. Nel 1950 il libro venne persino condannato dal Vaticano e messo all’Indice dei libri proibiti.
Quasi tutti, sia da destra che da sinistra, alla sua uscita lo attaccano: nessuno vuole mostrare i vincitori nelle vesti di corruttori e i vinti in quelle di corrotti dalle circostanze dell’incontro, ma solo tutti insieme proiettati, nella visione acritica e messianica di un’Italia che per merito degli Americani (vedi aiuti del piano Marshall) risorgerà tra poco ai fasti di “un paese industrializzato”; e proiettati in quella dignità popolare espressa durante la Liberazione che non può mai tradursi nella miseria morale e nella degradazione.
Malaparte, incurante del pensiero dominante, affonda spietatamente la sua analisi in questa via crucis che percorre, insieme ai suoi compagni d’arme americani e in specie con il Colonnello Hamilton, i vari quartieri di Napoli, dai più eleganti ai più degradati, dai palazzi ai bassi napoletani, provando a farsi interprete delle due facce di questa umanità chiamata dalla Storia a incontrarsi.
Fin dalla prima pagina del romanzo vincitori e vinti sono messi a confronto attraverso la dolorosa ironia del narratore e da subito il vinto si presenta come attore di una tragicommedia a uso esclusivo dei vincitori: un popolo vinto che non si sente tale e che per tutto il romanzo sfuggirà alle etichette che il vincitore tenterà di mettere su tutto ciò che non comprende della sua drammatica contradditoria identità.
Tutto è feroce scambio in questa Napoli stordita dal bisogno, dove l’unica legge è quella della sopravvivenza e dove per salvare la pelle bisogna modellarsi sull’immagine del liberatore, ma solo per recita, per il gioco crudele che la Storia ha imposto a vincitori e vinti.
È questa la certezza che si fa strada per tutto il romanzo: che il valore umano dei vinti (i Napoletani) è superiore a quello dei vincitori (gli Alleati Nordamericani), non importa quanto in apparenza degradata appaia la loro umanità nello specchio deformato dell’altro. Da questo romanzo è stato tratto il coraggioso film omonimo del 1981, diretto da Liliana Cavani, con la splendida interpretazione di Marcello Mastroianni, che ebbe il gran merito di rimettere in circolazione l’interesse per questo libro ingiustamente trascurato, per molto tempo, sia dai lettori che dalla critica.


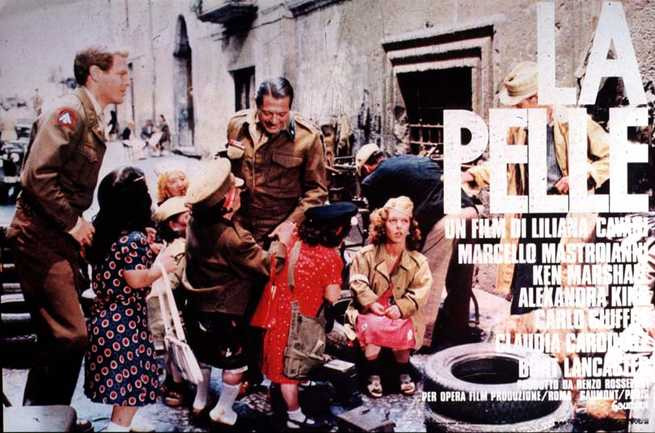
Lo studio sul brigantaggio non è semplice, «è costantemente esposto al pericolo di frammentarsi nell’analisi di un fenomeno complesso e confuso nelle sue manifestazioni, per alcuni versi ancora tanto oscuro […] e quindi tutto sia frazionato, particolare, caotico». La storia di quel complesso fenomeno storico sociale, politico, culturale e militare che va sotto il nome di “grande brigantaggio” è un fenomeno complesso e sanguigno, che si manifestò in coincidenza con il processo di unificazione, manifestandosi in forme molto vaste soltanto dalla fine del 1860, in coda alla spedizione dei Mille, e fino all’incirca al 1866, le sue radici erano radicate nei decenni precedenti, e neanche i Borbone erano riusciti a sradicarlo, quando ci provarono, a partire dagli anni Venti dell’Ottocento, dopo averlo sfruttato nel 1799 per le variegate truppe sanfediste del Cardinale Ruffo. Tuttavia dall’autunno 1860 fino al 1864 e oltre le bande dei briganti si moltiplicano e crescono periodicamente, dimostrando capacità militari sorprendenti, sciogliendosi e ricomponendosi rapidamente. Quando nel 1860 i piemontesi invasero, occuparono e annessero il Regno delle Due Sicilie, i briganti si moltiplicarono. La rivolta esplode e dilaga, ad alimentarla ci sono motivi sociali e politici; v’è il tentativo dei Borbone di riprendersi il Regno. I “galantuomini” liberali all’inizio avevano appoggiato lo sbarco e l’avanzata garibaldina. Occupando i territori, togliendo il potere ai borbonici, in nome di Vittorio Emanuele. Di fronte a queste minacce i borbonici reagiscono, ricorrono alla sollevazione contadina per reprimere la rivoluzione borghese. I contadini cooperano con le forze borboniche, al comando del colonnello Teodoro Klitsche de Lagrange, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 1860, si cerca di ripristinare ovunque l’autorità borbonica, abbattendo i governi rivoluzionari.
«Il successo di questo piano fu quasi travolgente […] Il Klitsche respinse in un vivace combattimento a Civitella Roveto i Cacciatori del Vesuvio di Pateras, raggiunse Avezzano, e alla fine di ottobre, minacciava addirittura l’Aquila dall’altopiano di Rocca di Mezzo». La rivolta dei contadini dilagava violenta specialmente nell’Alto Molise e nel Sannio, i rivoluzionari sono costretti a fuggire e a rifugiarsi sotto la protezione dell’esercito piemontese. In poche settimane si assiste a passaggi di potere e a scontri sanguinosi, furono rialzati gli stemmi borbonici, abbattuti dai rivoluzionari.
In Sicilia invece i contadini siciliani in uno primo tempo appoggiano Garibaldi, «ma quando i loro obiettivi di classe li spingevano ad attaccare la borghesia agraria nei suoi organismi di potere locali, le municipalità e la repressione garibaldina si riversava su di loro». La mancanza di un “partito” borbonico in Sicilia, non ha permesso di sfruttare questa delusione dei contadini ed organizzare la loro reazione. Per la borghesia liberale l’unica salvezza per domare la rivolta contadina, veniva dall’invocare «l’annessione incondizionata e l’arrivo dell’esercito “piemontese”, abbandonando la dittatura garibaldina che disturbava con talune misure di carattere democratico gli interessi costituiti, senza peraltro garantire la proprietà terriera dagli attacchi dei ‘cafoni’». Ma i vari dirigenti del governo a Torino, a partire da Farini, Fanti, Della Rocca e lo stesso Cavour, sottovalutarono la sollevazione contadina a direzione reazionaria. Pensavano che una volta dispersi e allontanati i garibaldini e caduta Gaeta, «l’obiettivo di pacificare il Mezzogiorno e di restaurarvi l’autorità statale, sarebbe stato praticamente conseguito».
Nell’inverno 1860-61 inizia il grande brigantaggio; bande armate si andavano costituendo un po’ dappertutto, vi accorrevano ex soldati borbonici già congedati o “sbandati”, renitenti ai richiami, disertori, evasi dalle carceri, contadini e montanari ansiosi di libertà, di bottino e di vendetta. E’ un susseguirsi di nomi di comandanti briganti e di località, di continui scontri con gli eserciti regolari provenienti dal Nord e con la Guardia nazionale. L’epicentro degli scontri è stata la Basilicata nei boschi del Volture e di Lagopesole, di Rionero, dove primeggiava Carmine Crocco con la sua nutrita banda ed il suo luogotenente Giuseppe Nicola Summa, detto Ninco-Nanco. Molfese, nell’appendice terza del suo libro, pubblica un elenco delle bande brigantesche attive fra il 1861 e il 1870 e ne individua ben 388 dalle piccole, composte di pochi individui (5-15), fino alle grandi, che raggiunsero e superarono talvolta i 100 uomini, con punte fino a 300-400. Fra le grandi bande, Molfese cita quelle di Giovanni Piccioni, Giacomo Giorgi, Berardo Stramenga nell’Abruzzo Teramano ed Aquilano; di Pasquale Mancini e Salvatore Scenna, Domenico Valerio [Cannone] e Policarpo Romagnoli, Giovanni Di Sciascio, Domenico Saraceni (Pizzolungo) nell’Abruzzo Chietino; di Domenico Coja (Centrillo), Luigi Alonzi (Chiavone), Cedrone, Capoccia, Alessandro Pace, Francesco ed Evangelista Guerra, Domenico Fuoco, Luigi Andreozzi, il generale Rafael Tristany nella Terra di Lavoro, Sorano e Stato Pontificio; di Nunzio di Paolo, Giuseppe Schiavone nel Molise, Sannio e Beneventano; di Cipriano e Giona La Gala, Agostino Sacchitiello nell’Irpinia e Salernitano; di Carmine Donatelli (Crocco), Giuseppe Nicola Summa (Ninco-Nanco), Giovanni Fortunato (Coppa), Paolo Serravalle, Pasquale Cavalcante, Donato Tortora, Angelo Antonio Masini, Giuseppe Caruso in Basilicata; Michele Caruso, Angelo Maria Villani (lo Zambro) in Capitanata; Sergente Romano in Terra di Bari e Terra d’Otranto; Mittica in Calabria; Vincenzo Barone in Provincia di Napoli. Crocco al suo comando aveva formato una vera e propria costellazione di bande guidate da risoluti ed astuti capi contadini. Queste bande arrivarono a minacciare anche i grossi centri del Meridione come Caserta, Benevento, Potenza. E vi sono anche le brigantesse (Dinella, Marinelli, Pennacchio, Ciccilla).
«Le forze dell’esercito e le guardie nazionali sostennero il peso della lotta con non poca difficoltà. Il nemico agiva di sorpresa, mobilissimo, si ritirava fulmineamente dopo aver colpito, tendeva agguati continui, si batteva soltanto in condizioni favorevoli di tempo, di luogo e di forze. Le continue perlustrazioni non davano risultati apprezzabili; le piccole bande sfuggivano ad ogni rete: le bande più grosse, non appena strette davvicino, si frazionavano e si disperdevano. Gli scontri […] si riducevano in genere ad uno stillicidio di scaramucce con perdite esigue da ambedue le parti, ma che comportavano un grande logorio di forze fisiche […]». Meglio di così non si può descrivere la guerriglia ingaggiata dai briganti con i militari regolari.
La repressione ad opera dei piemontesi è spietata. La magistratura militare sostituisce quella ordinaria. «Cialdini impresse alla repressione un carattere spietato, la lotta non conobbe più quartiere e particolarmente efferate furono le rappresaglie indiscriminate sulle popolazioni insorte». Attorno ad un nucleo fisso di capi, o di soldati retribuiti inizialmente dai sostenitori di Francesco II. Molti erano briganti occasionali, come per un secondo o terzo lavoro, il che rendeva e rende difficile una seria contabilità storica. Sulle dimensioni numeriche delle bande e sui caduti disponiamo di tempi, più che di cifre precise, nel tempo rivalutate dalle 5.500 tra 1861 e 1864 secondo le prime ricerche di Molfese, le 8.500 secondo Enzo Ciconte, e le 15.000 vittime circa secondo Ciocca. Ma come scrive Pescosolido «pur sempre di un sacrificio di sangue superiore a quello di tutte le guerre di indipendenza risorgimentali». Sotto il governo di Bettino Ricasoli venne, ancora una volta, la repressione. Durissima e spietata come non mai. La barbarie della repressione con metodi ancor più feroci di quelli dei francesi venne accompagnata da una scaltra campagna di disinformazione: le regioni del Sud erano ancora una volta abitate dai diavoli, e contadino equivaleva a brigante. Se non si era brigante si era fiancheggiatore. I meridionali divennero, così, una razza maledetta, come nel saggio di Vito Teti che ha per titolo, per l’appunto, La razza maledetta. Venne, infine, decretato lo status quo in ordine alla questione demaniale con una legge del 1876, che legittimò l’usurpazione delle terre. Intanto, nel 1863 era stata emanata la famigerata Legge Pica che diede poteri speciali ai militari. Non è possibile riportare qui la mole di informazioni circa questo periodo crucciale della storia della Calabria e di tutto il Sud. Per tutti basti il giudizio di Antonio Gramsci: “Lo Stato italiano […] ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole, crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi i contadini poveri che gli scrittori salariati tentarono di infamare con il marchio di briganti”. Il governo Ricasoli nascondeva o minimizzava i fatti del brigantaggio non solo nel Paese ma anche all’estero. Si pensi che il rapporto Massari, ma anche quello di La Marmora sono stati segretati, il popolo non ne era a conoscenza. Il dibattito diventa acceso su cosa fare con il Mezzogiorno, viene redatto un documento, una ‘circolare’ dal capo del governo, Massimo D’Azeglio risponde che se i “napoletani” sono contrari all’unità, «non credo che noi abbiamo il diritto di prenderli a fucilate». Mentre Ricasoli ribadisce che c’era stato il plebiscito e che la nazione non poteva concedere a nessuna parte del Paese il diritto di separarsi. Inoltre si nega qualsiasi carattere politico all’azione del brigantaggio, in quanto svolto da “volgari assassini”, che agiscono di propria iniziativa, senza guide legittimiste o di ufficiali borbonici. Del resto per i governanti di Torino, il brigantaggio infestava soltanto cinque delle quindici provincie meridionali. Poi a causa delle rappresaglie ordinate da Cialdini sulle popolazioni, si nota un cambiamento di strategia delle bande e della guerriglia. Non si puntò più a invadere i paesi, ma a colpire i grandi possidenti, le loro terre e il loro bestiame. Preferirono adottare agguati e affrontare piccoli drappelli isolati di soldati e di guardie nazionali. Nella repressione l’esercito sardo-piemontese che si avvale della Legge Pica è il protagonista assoluto, con l’arbitrarietà dello stato d’assedio dei vari generali nei confronti dei “cafoni” meridionali. Bisogna distruggere radicalmente il brigantaggio mettendo a ferro e fuoco il Sud. Appare impressionante il numero di quasi 120.000 soldati impegnati dal governo “liberale” piemontese nell’opera di repressione, testimoniando come il brigantaggio in quegli anni sia stato un fenomeno di massa, che andava ben al di là dei briganti alla macchia. Si intendeva spargere un “salutare terrore” tra i briganti ed i loro sostenitori. Ma alla domanda quanti furono gli arrestati? E’ praticamente impossibile stabilirlo. Le fonti governative forniscono dati ridicolmente esigui. Si pensi che nella sola Sicilia in un anno ci furono quattromila arresti. Equanti furono i briganti fucilati o uccisi? Il numero preciso non lo si saprà mai, ma furono tantissimi. Molfese, dal secondo bimestre del 1861 e tutto il 1865, ne documenta 5.212. Ma si parla anche che i guerriglieri caduti in combattimento in quel decennio furono 155.620 e i fucilati o morti in carcere 120.327. Un massacro. L’olocausto del Sud.
Un fenomeno intricato, sulle cui cause gli storici non hanno mai cessato di interrogarsi. Nel grande brigantaggio confluirono sia una sorda rivolta contro il presente, sia una congerie di faide locali, sia le culture coeve della violenza, sia le speranze di restaurazione e di riaffermazione del potere secolare ecclesiastico. Non vi è dubbio che inizialmente, nel 1861, una componente importante delle insorgenze fu alimentata dal legittimismo borbonico e dalla sua promessa di quotizzazione dei demani, che né Garibaldi né Cavour furono in grado di esaudire. Il brigantaggio non fu un fenomeno meramente ideologico. Perchè è figlio della rabbia che si produce con la miseria e la fame di terra, l’odio maturato dalla popolazione rurale nel corso di tutto l’Ottocento contro i possidenti i cosiddetti “galantuomini”, ma poi non si spiega come mai il fenomeno si dispiegasse ancora e in forme criminali dal 1862 in poi – trascinandosi fino al 1870 e oltre – quando le speranze di restaurazione erano tramontate. I meridionali come gli ebrei, vengono discriminati per la loro ‘razza’; il Mezzogiorno come territorio coloniale, dove tutto era permesso agli ‘invasori’; rimossi i meridionali liberali, i protagonisti del 1848 nei garibaldini; il passato borbonico divenne così come una sorta di originario paradiso perduto. Di fronte a tali processi, profondi e diffusi, lo stato unitario non ha avuto una propria politica della memoria, non sapendo quindi offrire al Meridione d’Italia, anzi ai suoi vari Meridioni, una versione adeguata del processo di Unificazione. Troppo pochi, peraltro, sono stati gli storici che si sono posti questo problema (a la loro giustificazione, comunque, un problema più delle istituzioni e della politica che della storiografa). D’altronde, proprio una versione ufficiale dell’Unificazione privata dalle asperità delle sue contraddizioni sociali e politiche possono ingannare e finire per presentare quella brigantesca come l’unica forma di opposizione sociale alla ‘guerra regia’ e all’unificazione in una ‘rivoluzione passiva’. Si cancella così la memoria dei liberali, dei democratici, dei garibaldini e dei mazziniani che sognavano un’altra Italia e per essa combatterono. Infine, in ambienti anarchici così come in ambienti di destra radicale la riproposizione di visioni romantiche del brigante come masnadiero “schilleriano” può trovare una sua collocazione. Attorno al brigantaggio bisogna ampliare lo sguardo al suo “manutengolismo”, cioè ai ceti e alla società politica che lo sosteneva, e più in generale alla società civile nelle sue diverse articolazioni territoriali. Anche Molfese aveva guardato non solo ai briganti ma alla società che li esprimeva: ma le categorie con cui vi guardava erano quelle dei suoi tempi, in cui si cercava di inserire tutto il Mezzogiorno dentro una unica questione sociale. La classe dirigente liberale e i suoi storici diedero spesso dei briganti un’immagine tutta negativa e criminalizzante, spesso sottacendo il consenso politico e sociale che essi avevano riscosso e dal quale la loro azione si era mossa. Più rari, ma suggestivi e durature, furono in quei decenni le ricostruzioni romantiche della guerra del brigante. Si mise in evidenza il dato di lungo periodo di un Meridione solcato da forme di insubordinazione e di ‘malandrinaggio’, fu possibile mettere l’accento sulle diversità territoriali nelle forme tattiche, nei risultati e nei consensi dell’azione brigantesca, l’articolazione delle bande in sottogruppi, le differenze tra bande costituite da contadini, da sottufficiali e da ex soldati o da pastori, si esaltò il dato della conflittualità fra unitari e antiunitari nelle vicende politiche locali. Insomma si misero in discussione alcuni aspetti delle interpretazioni precedenti, ma nell’insieme senza rigettarli. C’è stato un ceto dirigente che ha imposto uno Stato unitario anti-cattolico, non rispettoso delle altre entità statali della penisola, diverse per storia, costumi e cultura. La questione meridionale nacque allora, così pure quella cattolica e quella federale. È un processo storico che merita di essere riconsiderato. Ma quali sono le cause reali della sconfitta del brigantaggio antisabaudo?: La grande emigrazione transoceanica, che ridusse la pressione sociale; le predicazioni socialista e cattolica, che incanalarono verso forme di protesta sociale lecite le rivendicazioni dei contadini poveri del Sud. Il brigantaggio uscì, così, dalla “storia” ed entrò definitivamente nel “mito”.




La visita in Italia dei reali d’Inghilterra con lo storico discorso, il primo in assoluto di un sovrano britannico in una seduta congiunta del Parlamento italiano, pronunciato nell’aula di Montecitorio da Re Carlo III. Purtuttavia, al di là dei calzanti riferimenti letterari a Dante e Virgilio, dello spiccato senso dell’umorismo dimostrato in più occasioni dal monarca inglese, e del lodevole impegno da questi profuso nell’esprimersi correttamente in lingua italiana, esiste un aspetto cruciale, ad oggi (volutamente?) trascurato, su cui varrebbe la pena centrare il focus dell’attenzione. Proviamo a farlo ponendoci un quesito: qual è la vera essenza del discorso pronunciato alle Camere da Re Carlo, il reale significato del messaggio che il sovrano britannico ha voluto far arrivare? Un evento cruciale che ha segnato, nel bene o nel male, la storia del Belpaese, contribuendo a mutare drasticamente il corso degli eventi e, pertanto, i destini del popolo italiano. Riferendosi all’Unità, Carlo III, con le sue parole, ha chiaramente inteso rivendicare il ruolo giocato da Londra nella vicenda, risultato poi decisivo al fine di indirizzare gli eventi nella “giusta direzione”. Un po’ come a dire: è merito nostro se s’è fatta l’Italia unita.
Adesso cosa diranno i soliti tromboni risorgimentali delle “tesi neoborboniche”, se si è addirittura scomodato il reale inglese confutando che gli inglesi e la massoneria sostennero dal punto di vista logistico ed economico i Mille & Compagni?
“Due le navi inglesi che vegliavano durante lo sbarco a Marsala”. Peccato che il re non abbia detto perché lo fecero e non abbia chiarito la storia degli accordi con i Savoia e dei disaccordi con i Borbone (fin dalla guerra degli zolfi e dei loro forti interessi nel Mediterraneo) o delle fake news diffuse dai vari Gladstone e compagni con le false “negazioni di Dio” già smentite da accademici famosi come John Davis.
“Molti degli “eroi” del Risorgimento – tra cui Cavour e Mazzini– trascorsero del tempo nel Regno Unito”. Un caso o una apposita ed efficiente organizzazione massonica (e non) preposta al raggiungimento dell’obiettivo-unificazione?
Quando Garibaldi visitò Londra nel 1864 per ringraziare il popolo britannico del sostegno ricevuto [e insiste sul concetto], scoppiò una vera e propria Garibaldimania con mezzo milione di persone che accorsero a salutarlo fino alla creazione di un biscotto-omaggio ancora diffusissimo”.
Qui la tesi dovrebbe essere ancora più chiara: come si diffuse quella “mania”, in assenza di social e tv, se non con buone dosi di una massonica e massiccia propaganda?

All’arrivo della spedizione dei Mille l’11 maggio 1860, la presenza delle fregate inglesi davanti al porto di Marsala impedì la reazione della squadra borbonica che stava per intercettare e distruggere i due piroscafi garibaldini. Ma quali motivazioni portarono l’Inghilterra a decider di influenzare il processo unitario italiano? La risposta va cercata nei rapporti diplomatici tra Regno Unito e Regno delle Due Sicilie.
Tra il 1799 e il 1815 la gran Bretagna fu un alleato fondamentale per i Borboni. Dopo le due invasioni francesi i regnanti di Napoli fuggirono in Sicilia, protetti dalla flotta della Gran Bretagna, che stabilì un effettivo protettorato sull’isola. “Quest’isola non rappresenta per l’Inghilterra soltanto un importante avamposto strategico, da preservare ad ogni costo, da una possibile occupazione della Francia che la minaccia dalle sue coste, ma costituisce anche il centro di tutte le operazioni militari e politiche che il Regno Unito intende intraprendere nell’Italia e nel Mediterraneo”. Gli inglesi svilupparono ottimi rapporti commerciali con l’isola. Una quota rilevante della bilancia commerciale britannica era rappresentata dall’importazione di materie prime provenienti dalla Sicilia e soprattutto dallo zolfo. In Sicilia erano presenti vere e proprie dinastie di mercanti inglesi, le quali avevano ottenuto il monopolio per lo sfruttamento di questa importante risorsa.
La situazione cambiò nel 1830, quando salì al potere Ferdinando II. Egli si pose l’obbiettivo di rendere il Regno delle Due Sicilie una potenza di media grandezza, autonoma da ingerenze esterne all’interno dello scacchiere europeo. Prima occasione di scontro fu la questione dell’isola Fernandea, un lembo di terra di circa quattro chilometri quadrati emerso dal mare tra Sciacca e Pantelleria all’inizio del 1831. A causa della sua posizione strategica, le varie potenze si contesero il dominio dell’isola. Il primo a rivendicarne la sovranità fu il capitano inglese Humphrey Fleming Jenhouse battezzandola ‘Isola Graham’. In seguito si fece avanti anche la Francia, che inoltrò sul luogo una spedizione scientifica, che si concluse con il posizionamento di una nuova bandiera e di un nuovo nome, ‘Iulia’. Poco dopo, Ferdinando II inviò una spedizione che ribattezzò l’isola in Ferdinandea, informando successivamente francesi e inglesi dell’accaduto sottolineando che la nuova isola era emersa in acque siciliane e che, quindi, apparteneva al Regno del sud. Ma prima che si rischiasse di giungere ad un conflitto, l’isola sprofondò nuovamente l’8 dicembre 1831. Un altro motivo di attrito fu la decisione di Ferdinando II di non appoggiare nel 1834 Isabella II nelle guerre carliste per la successione di Ferdinando VII. La regina era appoggiata da Francia e GB, che presero la decisione come un atto di insubordinazione.
Per ristabilire una forte influenza sulla Sicilia, quando nel 1848 da Palermo cominciarono i moti che infiammarono il continente per i due anni successivi, l’Inghilterra sostenne il governo separatista siciliano, allo scopo di farne uno Stato autonomo retto da un principe di Casa Savoia. Ma la sconfitta di Carlo Alberto nella prima guerra d’indipendenza permise a Ferdinando II di intervenire in Sicilia e ristabilire la propria egemonia sull’isola. Il Regno Unito accusò il governo di Napoli di essere causa del malgoverno che scatenò le proteste e in una nota inviata al governo di Napoli minacciò che “qualora Ferdinando II avesse violato i termini della capitolazione e perseverato nella sua politica di oppressione, il Regno Unito non avrebbe assistito passivamente a una nuova crisi tra il governo di Napoli e il popolo siciliano”. A inasprire le relazioni contribuirono le due lettere di Gladstone a lord Aberdeen (premier in carica), pubblicate su tutti i maggiori giornali europei durante il 1851. L’esponente liberale denunciò le dure condizioni delle carceri napoletane, scrivendo che il governo delle Due Sicilie era “la negazione di Dio eretta a sistema di governo”.
I rapporti furono sul punto di rottura definitivo a causa dello scoppio della guerra di Crimea. Ferdinando II decise di non appoggiare Francia e Gran Bretagna durante il conflitto (a differenza del Piemonte) poiché riteneva probabile una vittoria russa. Palmerston, primo ministro inglese, accusò la corona borbonica di essere divenuto vassallo della Russia. Si stava addirittura preparando una dimostrazione navale nel golfo di Napoli allo scopo di favorire un’insurrezione contro la dinastia in carica per sostituirla con una monarchia costituzionale, ma fu annullata per decisone della Regina Vittoria. Un editoriale del “Times” sosteneva che questa iniziativa raccogliesse il favore dell’opinione pubblica e che dovesse avere un effetto simile della spedizione dell’ammiraglio Perry in Giappone che provocò il crollo del dello shogunato Tokugawa.
Con il Regno del Sud isolato diplomaticamente, quando Garibaldi decise di intraprendere l’impresa dei Mille il Regno Unito decise di agevolarne la riuscita. Impedì alla flotta francese di affondare i garibaldini che attraversavano lo stretto per dirigersi in Calabria e favorì l’alleanza tra la malavita napoletana e gli insorti. In questo modo la Gran Bretagna riuscì ad avere una forte influenza sul nuovo Stato unitario. Come scrisse Palmerston in una lettera alla regina Vittoria, “considerando la generale bilancia dei poteri in Europa, uno Stato italiano unito, posto sotto l’influenza della Gran Bretagna ed esposto al ricatto della sua superiorità navale, risultava il miglior adattamento possibile(…) l’Italia non parteggerà mai con la Francia contro di noi, e più forte diventerà questa nazione più sarà in grado di resistere alle imposizioni di qualsiasi Potenza che si dimostrerà ostile al Vostro Regno”. Nel maggio ’60, la scena passò a Giuseppe Garibaldi e ai suoi Mille, con le navi da guerra di Sua Maestà britannica schierate nella baia di Marsala per proteggere lo sbarco. Scontato anche il fatto che l’azione fu finanziata dagli inglesi, circostanza che – come scrive Di Rienzo – «la storiografia ufficiale ha sempre accantonata, spesso con immotivata sufficienza». Ora quindi non più possibile. Non mancano neppure le prove degli accordi tra camorra campana e insorti filo-garibaldini, per favorire la vittoria dell’Eroe dei Due Mondi. In una nota del 9 luglio 1860 inviata dal diplomatico Henry George Elliot al Foreign Office si legge che «numerose bande camorristiche erano pronte a scendere in campo per contrastare, armi alla mano, la mobilitazione dei popolani rimasti fedeli alla dinastia borbonica, per presidiare il porto in modo da facilitare uno sbarco delle truppe piemontesi, e per controllare le vie d’accesso a Napoli al fine di rendere possibile l’ingresso dei volontari di Garibaldi». Non mancarono i dissensi. In piena Camera dei Comuni il deputato conservatore parlò apertamente di «dirty affair» (sporco affare): una dura e sfrontata intromissione inglese negli affari della Penisola che si sarebbe ripetuta più volte nei decenni seguenti.

( Eugenio Di Rienzo nei due saggi “Il regno delle due Sicilie e le potenze europee – 1830-1861”, edito nel 2012 da Rubbettino, e “L’Europa e la questione napoletana – 1861-1870”, D’Amico Editore, 2016).
La storiografia unitaria canta le lodi del cosiddetto “decennio francese” (1804-1814), allorché il Regno di Napoli cadde sotto la dominazione francese ed ebbe come suoi re due francesi, Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, il primo fratello di Napoleone (cioè Leone di Napoli, stranezze della storia dei valori!); cognato il secondo. I meriti assegnati ai due sarebbero le riforme antifeudali e quelle amministrative. In effetti si trattò di carta inutilmente stampata, in quanto …restarono sulla carta, e se proprio ebbero qualche effetto pratico, esso fu nocivo alle popolazioni meridionali.
Quel che si omette, crocianamente, di raccontare è che essi regnarono solo su Napoli e sulle città maggiori, mentre, in tutte le regioni del Regno le campagne i paesi furono insanguinati da lotte feroci fra francesi e resistenti, nel corso delle quali vennero perpetrati dei veri genocidi. Decine di borghi, forse un centinaio, furono dati alle fiamme, i loro abitanti trucidati, le donne stuprate, i bambini precipitati dalle rupi.
Gli italiani che elogiano la dominazione francese sono in tutto e per tutto simili a quegli abissini, libici, greci, albanesi che stettero dalla parte di Mussolini quando l’esercito italiano ridusse a colonia il loro paese. Direi di più: simili a quegli ungheresi, polacchi, norvegesi e ucraini che stettero dalla parte di Hitler e seviziarono i loro concittadini. (Nicola Zitara).
Non era stato capace di tenere Napoli quando aveva un grande esercito ai suoi ordini, eppure [Murat] credeva che l’intero paese sarebbe insorto in suo favore contro Ferdinando. Aveva radunato circa duecentocinquanta seguaci ed equipaggiato sette feluche. “Non rinuncerò al mio Regno” disse a Carabelli [n.d.r. agente còrso]. “Basterà che mi faccia vedere per vincere”.
S’imbarcò [dalla Corsica] la sera del 28 settembre [1815]. La piccola flotta fu dispersa da una tempesta nei pressi di Napoli e la feluca di Murat con un’altra furono portate molto più giù. Il 7 ottobre, quando erano in vista di Sant’Eufemia, alcuni compagni di Murat insistettero perché andasse a Trieste, ma Barbara, il comandante della feluca, disse che avrebbe dovuto comunque approdare per rifornirsi di acqua e provviste. Cosi si diresse verso Pizzo, il porticciolo più vicino. Indubbiamente la fuga di Napoleone dall’Isola d’Elba aveva ispirato Murat. “Alla peggio morirò da Re”, aveva detto.
Si mise una magnifica uniforme ed un cappello piumato con una fibbia di diamanti, e alle undici di mattina scese a terra. Dalla riva, con il suo piccolo gruppo di uomini che gridavano “evviva Re Gioacchino”, andò direttamente alla piazza del mercato che essendo domenica era affollata; ma i popolani invece di unirsi all’applauso fuggirono di gran carriera come se avessero visto un fantasma.
Non avevano felici ricordi del regno di Murat: l’occupazione francese aveva rovinato il loro commercio costiero; molte famiglie erano imparentate con le vittime del generale Manhès [n.d.r. inviato in Calabria dal re francese per reprimere il cosiddetto brigantaggio], ed il magnate del distretto, il duca di Infantado, era un Grande di Spagna, i cui possedimenti erano stati confiscati sotto il regime da lui esecrato fin dal Dos de Majo del 1808.
Davanti alla postazione dei guardacoste c’erano dei soldati. Murat freddamente ordinò loro di seguirlo, e disse al loro sergente che lo promuoveva capitano; ma anche questi scapparono davanti allo sfarzoso intruso. Poiché la piazza del mercato s’era vuotata, Murat decise di andare a Monteleone [n.d.r. odierna Vibo Valentia], la grossa città più vicina, che era stata sempre favorevole alla Francia; ma quando si fermò per comprare un cavallo si era già riunita una folla ostile, e Trentacapilli, l’ufficiale di polizia, gli intimò di arrendersi.
Murat cercò di ricorrere ad un inganno (andava a Trieste, il suo passaporto era in ordine), ma la folla gli si fece addosso.
Vi fu una rissa: un colpo di pistola disperse la folla, e Murat con pochi dei suoi uomini corse alla spiaggia; ma le feluche erano scomparse. Stavano cercando di tirare in acqua la barca di un pescatore, quando furono raggiunti dai loro inseguitori. Uno dei compagni di Murat sparò, e venne ucciso.
Ne nacque uno spaventoso parapiglia in cui Murat riuscì a malapena a non essere fatto a pezzi. Molti dei suoi assalitori erano donne, una delle quali lo colpì in faccia strillando: “Tu parli di libertà ma mi hai fatto fucilare quattro figli!” Un’altra megera conservò orgogliosamente in un giornale un ciuffo di peli che gli aveva strappato dai baffi. Trentacapilli gli prese i documenti e la fibbia di diamanti.
Affamati, esausti, sanguinanti e laceri, gli invasori furono trascinati fino al castello e rinchiusi in una tetra cella. Gli altri erano stati circondati: settantanove in tutto.
Per mezzo di segnalazioni, il generale Nunziante, comandante della Calabria Meridionale, trasmise le notizie a Napoli e mandò a Pizzo un distaccamento di truppe agli ordini di un ufficiale comprensivo, mentre il cameriere del Duca di Infantado procurò a Murat abiti, cibo, vino e un dottore che ne medicasse le ferite.
Siccome Murat aveva ancora molti partigiani, specialmente nell’esercito, il Re [Ferdinando] era rimasto un po’ preoccupato di quella spedizione. Lo informarono dell’arresto di Murat mentre era al San Carlo, dove si rappresentava un’opera; immediatamente riunì il Consiglio, e Medici [n.d.r. Luigi de’ Medici, che allora era Ministro della Polizia] propose che Nunziante radunasse una commissione militare per giudicare Murat come nemico pubblico. Questo fu con tutta probabilità un consiglio di A’Court [n.d.r. diplomatico inglese], mentre l’ Ambasciatore Austriaco si ritirò prudentemente in campagna.
Il l3 ottobre Murat fu regolarmente giudicato da una corte marziale di ufficiali che egli stesso aveva promosso; dichiarato colpevole di incitamento alla guerra civile e di attacco armato contro il legittimo sovrano, fu condannato alla fucilazione.
Scrisse una commovente lettera a sua moglie, ed il curato di Pizzo, uomo sincero e pio, lo persuase a confessarsi e gli dette l’assoluzione. “Mirate al cuore, ma risparmiate la faccia” disse egli calmissimo al plotone d’esecuzione, rifiutando di essere bendato. Lo sconsigliato eroe cadde senza un gemito.
Fu una fine indegna di una carriera cosi spettacolosa; ma è difficile concepirne una diversa in quella situazione.
[tratto da H. ACTON, I Borboni di Napoli, pagg. 723 e segg., Firenze 1985 – Giunti Martello Editore]

“Giacchino facette ‘a legge e Giacchino fuje acciso”.
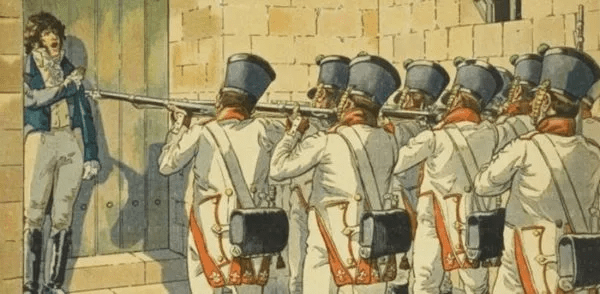
Gioacchino Murat, re di Napoli, fu fucilato a Pizzo Calabro il 13 ottobre 1815 con l’applicazione arbitraria della legge del 1808, emanata proprio da lui contro chiunque avesse attentato al legittimo potere costituito. Lui che ne era stato l’autore la subì terminando i suoi giorni con una condanna alla fucilazione.

Ernesto Galli della Loggia ha letto il libro “Cuore”, la piccola vedetta Lombarda, dagli Appennini alle Ande, ma non è mai stato in un archivio a scrutare queste cose orrende che vi proponiamo qui di seguito. La storia di Antonio Colucci l’ho ripresa dal libro di Michele Topa “I briganti di Sua maestà” e quella di Antonio Orsolino è stata ripresa dall’ Archivio Centrale dello Stato, Roma, Tribunale Militare di Guerra di Caserta, Cartella N° 37, dal sottoscritto.
Antonio Colucci, 16 anni
A Baiano, il 12 marzo del 1862, fu fucilato Antonio Colucci, un contadinello di 16 anni. Il ragazzo, per evitare uno scontro sul suo terreno coltivato, avvertì i patrioti dell’arrivo della truppa piemontese. Preso e interrogato dai savoiardi raccontò la sua verità. Lo condussero davanti ad un tribunale di guerra che gli inflisse la pena capitale. Otto militi della guardia nazionale furono prescelti per l’esecuzione, fra di essi vi era anche il compare del ragazzo. I colpi dei militi sbagliarono il bersaglio, pensiamo volutamente, non colpirono il contadinello in erba; allora quattro soldati piemontesi, afferrato il ragazzo, senza pietà lo stesero a terra. Il padre del ragazzo, impazzito, fu tradotto in carcere. (Michele Topa, I briganti di Sua Maestà, Editrice Fratelli Fiorentino di Fausto Fiorentino, Napoli.)
Orsolino Antonio, 12 anni, fucilato
Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta, dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa, dov’è la vittoria, le porga la chioma, che schiava della Padania Iddio non la creò, stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte…
Su! Meridionali! Cantate a squarciagola l’inno nazionale padano; carabinieri, finanzieri, guardie di pubblica sicurezza, calciatori azzurri, su, cantiamolo forte, è l’inno di Mameli!
Quale sentimento provarono i soldati del plotone di esecuzione che fucilarono Antonio Orsolino nato a Casalnuovo Monterotaro di Foggia, pastore ancora in erba, di anni 12 (dodici), domiciliato a Casalvecchio.
Fu preso sulle montagne tra Arienzo e Santa Maria a Vico il primo settembre del 1863 e giudicato dal tribunale di guerra di Caserta il 2 marzo del 1864 per il reato di brigantaggio secondo gli articoli 596 § 1 e 247 § 1 del Codice Militare. (Archivio Centrale dello Stato, Roma, Tribunale Militare di Guerra di Caserta, Cartella N° 37).
Il ragazzino andò fiero davanti al plotone di esecuzione, certo di imitare i suoi eroi, certo di aver difeso le sue pecore dalle ruberie piemontesi, certo di giocare a briganti e ladri, come si usava nel meridione. Aveva dodici anni! Agli ufficiali che condannarono il ragazzino un giorno dedicheremo una stele, un monumento di marmo bianco con la scritta “ Comandati dai Savoia a fucilare donne e bambini, siamo stati assassini e non soldati” .
Tratto dal libro” Le stragi e gli eccidi dei Savoia” di Antonio Ciano



“Briganti” è un crudo spaccato su quella che è stata a tutti gli effetti “la prima guerra civile italiana”. La guerra di resistenza di una nazione sovrana contro uno stato invasore che aveva come unico intento quello di accaparrarsi le casse del Regno delle Due Sicilie, floride e pingue, così da rinverdire le rachitiche finanze di uno stato indebitato e fallimentare come quello piemontese. L’aggressione, iniziata senza neanche una formale dichiarazione di guerra, era fortemente sostenuta da Francia, Inghilterra e massoneria. Il copione dell’opera è stato elaborato direttamente da documenti dell’epoca cercando di abbinare all’azione scenica, di alto impatto emotivo ed evocativo, una forte spinta all’informazione storica. Frutto al principio di una scrittura scenica collettiva nell’ambito del Progetto Smo Village 2003, con il contributo della casting Shyla Rubin e della sceneggiatrice Tiziana Masucci, nel corso del tempo è divenuto altro da sé. Un copione totalmente riscritto, integrando alle figure preesistenti della stesura originale (come Michelina De Cesare della quale si racconta il martirio) altri personaggi, fino a far divenire “Briganti” un racconto complesso su vari piani narrativi, con storie e vicende che collimano e si intersecano. Data la suggestione della messa in scena e la relativa novità delle tematiche trattate al tempo (oggi invece è reperibile una vastissima fonte di documenti e la realtà storica è emersa con forza) “Briganti” arrivò a sfiorare le 80 repliche. Ora è destinato solitamente ai primi anni del laboratorio di formazione. Teatro sociale e di parola ma non solo, il racconto di alcuni momenti significativi del periodo, con uno stile da “action movie”, ben si sposa con l’intento di far convergere alcuni degli emblematici personaggi della guerra di resistenza contro l’invasore Sabaudo a Scurcola. L’azione scenica e la memoria si snodano a ritroso, ricostruendo e immaginando tutto ciò che è avvenuto nei giorni antecedenti quello che è passato alla storia come “l’eccidio di Scurcola Marsicana” (di cui già dall’incipit conosciamo il drammatico finale). L’episodio, che è anche l’occhiello del testo, è raccontato anche da Pasquale Squitieri nel film “Li chiamarono… Briganti”. Davanti alla tristemente nota Chiesa delle Anime Sante a Scurcola Marsicana infatti, la notte tra il 22 e 23 gennaio 1861, avvenne uno dei tanti stermini compiuti dall’esercito piemontese, il cui “modus operandi” con “il diritto di rappresaglia” consisteva nella strage sistematica della popolazione civile, rea di coprire, foraggiare e combattere al fianco del regolare esercito borbonico o al fianco dei Briganti. Per capire gli eventi sarà però necessario rammentare che anche nei territori marsicani, in quegli anni, avevano luogo aspri scontri tra filo-borbonici e filo-piemontesi (il meridione d’Italia era governato da Francesco II, ultimo re delle Due Sicilie). Il 13 gennaio del 1861 a Tagliacozzo, si assiste all’ ennesimo violento scontro durante il quale i piemontesi sono messi in fuga e costretti a ripiegare fino ad Avezzano. La mattina del 23 gennaio 1861 il maggiore Delitala, giunto a Scurcola da Avezzano, come costume delle tristemente note “colonne infami” piemontesi dei criminali di guerra Pinelli e Quintili, esercita l’autoproclamato diritto di rappresaglia. I borbonici fatti prigionieri sono 366 e vengono rinchiusi nella Chiesa delle Anime Sante. E’ in questo momento che prende il via il terribile eccidio: borbonici o contadini e canonici e “quanti indiscriminatamente vi trovassero per le strade” vengono portati fuori uno alla volta e giustiziati. Tra le vittime una menzione particolare andrebbe al valoroso medico Giovanni Maúti di Luco dei Marsi, che meriterebbe un racconto a sé, avendo affrontato il plotone di esecuzione pur di non tradire i suoi compatrioti: avrebbe avuto salva la vita se lo avesse fatto. Il Maggiore Delitala, come da direttive del Generale Quintili, fece fucilare 89 persone nell’arco della maledetta notte e le fucilazioni sarebbero continuate se a mezzogiorno non fosse pervenuto un ordine da Avezzano col quale si “consigliava” al Maggiore Delitala di sospendere le fucilazioni. Oltre agli 89 trucidati si sono perse le tracce anche degli altri 277 (come detto furono 366 le persone recluse nella chiesa delle Anime Sante), si dice che furono condotti ad Avezzano per poter essere processati in seguito all’Aquila, ma non arrivarono mai a destinazione. Domenico Lugini racconta, con grottesco sentimento filopiemontese, che del trasferimento se ne fecero carico le “patriottiche guardie nazionali di Scurcola e di Magliano de’ Marsi”. E se mai vi fossero ancora dubbi, queste parole equivalgono alla certezza che i quasi 300 sventurati non arrivarono mai a destinazione, poichè era costume delle guardie nazionali risolvere sbrigativamente il “problema” prigionieri. Ad oggi, tra l’altro, non è ancora chiaro che fine abbiano fatto i cadaveri dei giustiziati. Si può presumere che una parte di essi sia stata sepolta ai piedi del Monte San Nicola, quello che sovrasta l’antico borgo di Scurcola, o siano stati bruciati o inumati in un’immensa fossa comune. Inebriato dal successo, reso ubriaco dal sangue versato, il tristemente noto comandante Pinelli, il 3 febbraio successivo inviò alla frazione di colonna mobile del 40° fanteria questo terrificante dispaccio: “Ufficiali e soldati! Voi molto operaste, ma nulla è fatto quando qualcosa rimane da fare. Un branco di questa progenie di ladroni ancora si annida fra i monti, correte a snidarli e siate inesorabili come il destino. Noi li annienteremo, e schiacceremo il sacerdotale vampiro che con le sozze labbra succhia da secoli il sangue dell‘Italia nostra, purificheremo col ferro e col fuoco le regioni infettate dall’immonda sua bava e da quelle ceneri sorgerà piú rigogliosa e forte la libertà!”. Il 40° fanteria piemontese dei criminali Pinelli e Quintili lo ritroviamo in Terra di Lavoro, in Molise, in Sicilia in eguali azioni di sterminio, ad Auletta, Arcocello, Valle dell’Agnone, Piedimonte d’Alife, Monaco di Gioia, Fontana di Campo, Castellammare del Golfo e in altre decine e decine di piccole località, letteralmente cancellate dalla cartina geografica. Le “prodezze” della colonna infame furono premiate con l’assegnazione di 2 medaglie d’oro agli “eroici” Pinelli e Quintili, 110 medaglie d’argento e 105 menzioni onorevoli alle “gloriose” truppe. Il Generale Pinelli è noto anche per un episodio successivo alla conquista del Regno delle Due Sicilie da parte di Garibaldi, che definì le operazioni piemontesi nel sud “cose da cloaca”. Comandante militare delle province parmensi, nell’ottobre 1860 venne messo alla testa delle forze italiane assedianti la cittadella di Civitella del Tronto, ancora in mano a una guarnigione dell’esercito delle Due Sicilie al comando del Maggiore Luigi Ascione. Nonostante la superiorità delle forze, le truppe comandate da Pinelli non riuscivano ad aver ragione degli assedianti. Pinelli adottò pertanto misure durissime contro la stessa popolazione civile e il 28 ottobre 1860, di fronte alla resistenza di Civitella del Tronto e alle insurrezioni di Caramanico, Avezzano, Sora, Carsoli, Pizzoli, decise la linea dura. Invase Pizzoli il 28 ottobre 1860, saccheggiò la città, la incendiò e fece strage di quanti tentarono di sottrarsi alle fiamme (nella sola mattinata uccise 136 innocenti, la maggior parte dei quali impiccati per risparmiare la polvere da sparo). La sera per dormire requisì la villetta del farmacista Alessandro Cicchitelli e frugando nei cassetti trovò i ritratti di Francesco II e di Maria Sofia. La mattina ordinò la fucilazione del farmacista davanti alla moglie implorante. Tutt’oggi non c’è una stima effettiva del numero dei civili massacrati dai carnefici di cui al contrario esiste un’infame e lunghissima lista. Questi feroci assassini sono stati infatti premiati con medaglie al valore e sono ricordati con strade intitolate a loro nome. Per oltre dieci anni i “liberatori” continuarono su questa gloriosa via: tra fucilazioni di massa, stragi e leggi speciali fino ad arrivare al genocidio che mai mente criminale avrebbe potuto concepire, l’eccidio delle 5000 anime a Pontelandolfo. Il 14 agosto del 1861, all’alba dell’Unità d’Italia, va in scena probabilmente la più nota delle stragi compiute dall’esercito Sabaudo, ai danni degli abitanti di due paesi, Pontelandolfo e Casalduni, in provincia di Benevento. Alle prime ore di quel maledetto giorno si scrive una delle pagine più nere del Risorgimento, puntualmente ignorata dalla storiografia ufficiale e dai testi scolastici. I protagonisti sono i “liberatori” piemontesi, con in testa l’infame Generale Enrico Cialdini. Dopo l’uccisione di alcuni soldati del regio esercito per mano dei briganti, su ordine di Cialdini, viene ordinata, come da costume piemontese, un’operazione di rappresaglia contro la popolazione civile. Sotto il comando del colonnello Pier Eleonoro Negri, una colonna di 500 bersaglieri viene inviata con la disposizione di massacrare tutti gli abitanti, ritenuti complici dei briganti, e di radere al suolo, per vendetta, i due paesi, che alle prime luci del 14 agosto i soldati raggiungono, sorprendendo gli abitanti nel sonno. I militari piemontesi assaltano così le chiese e le case: saccheggi, torture, incendi e stupri. Quella mattina accade di tutto. Le cronache dell’epoca raccontano che i militari davano fuoco alle abitazioni lasciando dentro gli abitanti mentre i bersaglieri attendevano l’uscita dei civili dalle proprie abitazioni in fiamme per sparargli addosso. Chi riesce salvarsi dalle fiamme e dal tiro a bersaglio viene catturato e poi fucilato. Per le donne c’era il solito trattamento a parte: cattura, stupro, sevizia e uccisione. Concettina Biondi, una ragazzina appena sedicenne, viene violentata a turno. Ecco la raccapricciante testimonianza dal diario del bersagliere Carlo Margolfo, uno dei 500 “gloriosi” bersaglieri protagonista della strage: “Al mattino del mercoledì, giorno 14, riceviamo l’ordine superiore di entrare nel Comune di Pontelandolfo, fucilare gli abitanti ed incendiarlo. Entrammo nel paese, subito abbiamo incominciato a fucilare i preti e gli uomini, quanti capitava, indi il soldato saccheggiava ed infine abbiamo dato l’incendio al paese, di circa 4500 abitanti. Quale desolazione non si poteva stare d’intorno per il gran calore e quale rumore facevano quei poveri diavoli che la sorte era di morire abbrustoliti e chi sotto le rovine delle case”. L’ordine è perentorio: radere al suolo i due paesi, non far rimanere in piedi neanche una sola pietra. Come già ricordato, vengono prese d’assalto le chiese e le case e, al grido di “piastra, piastra”, vengono saccheggiate per poi essere incediate. Negli ordini scritti ai suoi sottoposti, Cialdini era solito raccomandare di “non usare misericordia ad alcuno, uccidere senza fare prigionieri, tutti quanti se ne avessero tra le mani”. Ed è esattamente quello che avvenne ad opera di questo criminale di guerra, a Pontelandolfo e Casalduni, al quale nel nostro Paese sono dedicate numerose vie e piazze che sarebbe ora per decenza di cancellare! Al termine dell’azione il colonnello Negri telegrafò a Cialdini: “Ieri mattina all’alba giustizia fu fatta contro Pontelandolfo e Casalduni. Essi bruciano ancora”. Nel 1920 Antonio Gramsci, su “Ordine Nuovo”, a proposito di questi genocidi e di queste vere e proprie pulizie etniche perpetrate dei “civilizzatori e liberatori” italo-piemontesi a danno delle popolazioni meridionali, così scrive: “Lo Stato italiano si è caratterizzato come una dittatura feroce che ha messo a ferro e a fuoco l’Italia meridionale, squartando, fucilando e seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati tentarono di infamare con il marchio di briganti”. Si può senz’altro dire che la ferocia, per “diritto di rappresaglia”, dagli italo-piemontesi fu senza dubbio superiore a quella dimostrata, sempre per “diritto di rappresaglia”, dai nazisti nell’agosto del 1944 a Marzabotto e a Sant’Anna di Stazzema, dove gli abitanti furono anch’essi fucilati ma senza saccheggi e stupri e le case dei due paesi non furono bruciate, al contrario di quelle di Pontelandolfo e Casalduni di cui i piemontesi ne lasciarono intatte solamente tre. Eppure i nostri libri di storia e le enciclopedie non fanno altro che ricordare, perché giustamente non se ne perda la memoria, le vittime dei nazisti dell’agosto del 1944. Sarebbe doveroso ritrovare anche la memoria degli eccidi e delle operazioni di pulizia etnica di cui furono vittime le popolazioni meridionali ad opera di altri italiani, che si spacciarono per “liberatori e civilizzatori”. Assassini le cui gesta criminali vengono ancora oggi puntualmente ignorate dalla storiografia ufficiale e scolastica. Le passate celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia sarebbero state una buona occasione per ricordare e ritrovare una memoria condivisa. Le parole di Giuliano Amato, presidente del comitato dei garanti, che riportiamo di seguito, sono state solo scuse tardive e grottesche, che confermano che questi fatti non sono mai stati riportati nei libri di storia. Amato ha dichiarato agli abitanti di Pontelandolfo: “A nome del presidente della Repubblica Italiana vi chiedo scusa per quanto qui è successo e che è stato relegato ai margini dei libri di scuola”. Qui, stanchi di tanto sangue, ci fermiamo con le descrizioni di alcune delle imprese dei nostri prodi liberatori. Diceva Leonardo Sciascia: “Questo è un Paese senza memoria e io non voglio dimenticare”. E neanche noi vogliamo dimenticare Scurcola, Pontelandolfo, i paesi scomparsi e mai ricostruiti e i milioni di connazionali costretti ad emigrare davanti alle macerie di una nazione depredata. Non vogliamo dimenticare le migliaia di meridionali ex soldati dell’esercito del Regno delle Due Sicilie, i Briganti-combattenti, i renitenti alla leva, gli oppositori politici e tutti i conterranei squagliati nella calce nei campi di concentramento e sterminio di Fenestrelle e San Maurizio Canavese. I piemontesi furono maestri in tutto dei nazisti, anche del triste motto ancora inciso nel lager di Fenestrelle “ognuno vale non in quanto è ma in quanto produce” che diverrà ad Auschwitz “Arbet macht frei” – “Il lavoro rende liberi”. Gli orrori del primo campo di concentramento europeo sono stati raccontati con terrificante lucidità anche dal giornale piemontese L’Armonia (“La maggior parte dei poveri reclusi sono ignudi, cenciosi, pieni di pidocchi e senza pagliericci. Quel poco di pane nerissimo che si dà per cibo, per una piccola scusa si leva e, se qualcuno parla, è legato per mani e per piedi per più giorni. Vari infelici sono stati attaccati dai piedi e sospesi in aria col capo sotto ed si fecero morire in questa barbarie” ) o in maniera più poetica dal pastore valdese Georges Appia che, nell’ottobre del 1860, e siamo solo all’inizio delle deportazioni, in visita al forte che già rigurgitava prigionieri meridionali, così ebbe a descriverli: “Laceri, ignudi e poco nutriti, appoggiati a ridosso dei muraglioni nel tentativo disperato di catturare i timidi raggi solari invernali, ricordando forse con nostalgia il caldo dei loro climi mediterranei soffocato dal sangue e molti altri non si trovano più né vivi, né morti. E’ una barbarie signori”. Per concludere non vogliamo dimenticare quello che il sud era prima della depredazione, ricordando quanto inciso su una roccia calcarea sulla “Tavola dei Briganti” nella Majella: “Nel 1820 nacque Vittorio Emanuele Re d’Italia. Prima era il regno dei fiori, ora è il regno della miseria.”
Tantissime storie parlano della Sicilia, la più grande isola del Mediterraneo che affiora in uno dei mari più belli del mondo. Giuseppe Pitrè, storico di tradizioni popolari, riporta che, proprio secondo un’antica leggenda, Palermo fu fondata da un ignoto navigatore giunto in tempi antichissimi sui lidi della Conca d’Oro. Affascinato da quella terra che egli stesso definì “beata” decise di erigervi una città che per la sua bellezza e l’incantevole posizione, diverrà terra di conquista e motivo di orgoglio delle grandi civiltà classica, ellenistica, romana, bizantina, arabo – normanna ed ancora, sveva, angioina, spagnola e borbonica. Qui finisce la leggenda ed inizia la vera storia della Sicilia e di Palermo, il cui nome deriva dall’antico greco Panormos “tutto porto” proprio ad indicare la ricchezza di ormeggi ed i buoni fondali che, tutt’oggi, caratterizzano il suo porto.
Le vicende storiche del porto di Palermo sono intimamente legate a quelle della città in quanto, in ogni tempo, le configurazioni dell’agglomerato urbano e del suo porto si sono reciprocamente condizionate.
Risale all’ VIII secolo A.C. la nascita del primo nucleo urbano – ad opera dei Fenici – nel sito dove sorge l’attuale centro storico della città, un tempo emporio utilizzato per gli scambi commerciali con le popolazioni locali. Per molti secoli Palermo divenne la base strategica dei Cartaginesi nel Tirreno e, conseguentemente, obiettivo primario della politica commerciale dei Romani che, dopo numerosi e vani tentativi, nel 254 A.C. riuscirono ad espugnare la città e porvi le basi di quella che sarà un intensa attività marinara, come testimonia l’abbondante materiale archeologico rinvenuto. Sino al VI secolo d.C. il porto mantenne inalterate le sue principali caratteristiche. Con la conquista araba (830 – 1071), anche il porto di Panormus divenne centro di gran parte del traffico tra i paesi arabi del Mediterraneo; fu in questo periodo che si ebbe la prima grande trasformazione del paesaggio portuale con la costruzione della cittadella fortificata (al Halisah, la Kalsa) a protezione delle strutture amministrative e militari esistenti.
All’inizio del XI secolo, il decadere della potenza musulmana ed il crescente pericolo delle flotte delle repubbliche marinare indussero gli Arabi a fortificare la città e a chiudere l’imboccatura del porto con una grossa catena (che partiva dalla Chiesa che prese appunto il nome “della Catena” in prossimità della Cala); nello stesso periodo venne costruito un forte a difesa del porto, il Castello a mare, presso l’odierno Molo Trapezoidale.
Con l’espugnazione della città ad opera dei Pisani nel 1064 e l’occupazione normanna, si assistette ad un’intensa attività portuale. Il progressivo interramento del porto, causato dai detriti riversati dai fiumi Kemonia e Papireto, ridussero sempre di più la superficie degli specchi acquei fino all’attuale configurazione della Cala. Si rese pertanto necessario costruire, nel 1575, il primo tratto del “Molo Sud”; l’anno successivo si diede inizio alla costruzione del Molo Nord, spostando così l’ambito portuale verso nord (attuale allocazione) e lasciando pian piano l’antico porto, la Cala, al naviglio minore. L’attuale porto di Palermo vide la sua nascita, per volontà del Viceré di Sicilia García Álvarez de Toledo y Osorio, essendo l’antico porto della Cala insufficiente e troppo angusto per le crescenti esigenze cittadine. Essendo il lato Sud della Cala occupato dalla passeggiata della marina, si scelse, come luogo di sviluppo per la nuova zona portuale, il lato Nord del centro abitato presso il nuovo quartiere di Santa Lucia (l’attuale Borgo Vecchio), fondato da Carlo d’Aragona Tagliavia nel 1570, che, proprio in funzione del porto, andò poi a sviluppare un carattere tipicamente marinaro.

Nel 1590, quando i lavori del Molo Nuovo furono ultimati, fu posto, all’ingresso del porto, un cippo in memoria dell’avvenuta costruzione. Il cippo, sormontato dall’aquila palermitana, presenta, su uno dei quattro lati, lo stemma del Viceré García de Toledo e, su un altro lato, la più antica raffigurazione esistente del Genio di Palermo. Tantissime storie parlano della Sicilia, la più grande isola del Mediterraneo che affiora in uno dei mari più belli del mondo. Giuseppe Pitrè, storico di tradizioni popolari, riporta che, proprio secondo un’antica leggenda, Palermo fu fondata da un ignoto navigatore giunto in tempi antichissimi sui lidi della Conca d’Oro. Affascinato da quella terra che egli stesso definì “beata” decise di erigervi una città che per la sua bellezza e l’incantevole posizione, diverrà terra di conquista e motivo di orgoglio delle grandi civiltà classica, ellenistica, romana, bizantina, arabo – normanna ed ancora, sveva, angioina, spagnola e borbonica. Qui finisce la leggenda ed inizia la vera storia della Sicilia e di Palermo, il cui nome deriva dall’antico greco Panormos “tutto porto” proprio ad indicare la ricchezza di ormeggi ed i buoni fondali che, tutt’oggi, caratterizzano il suo porto.
Le vicende storiche del porto di Palermo sono intimamente legate a quelle della città in quanto, in ogni tempo, le configurazioni dell’agglomerato urbano e del suo porto si sono reciprocamente condizionate.
Risale all’ VIII secolo A.C. la nascita del primo nucleo urbano – ad opera dei Fenici – nel sito dove sorge l’attuale centro storico della città, un tempo emporio utilizzato per gli scambi commerciali con le popolazioni locali. Per molti secoli Palermo divenne la base strategica dei Cartaginesi nel Tirreno e, conseguentemente, obiettivo primario della politica commerciale dei Romani che, dopo numerosi e vani tentativi, nel 254 A.C. riuscirono ad espugnare la città e porvi le basi di quella che sarà un intensa attività marinara, come testimonia l’abbondante materiale archeologico rinvenuto. Sino al VI secolo d.C. il porto mantenne inalterate le sue principali caratteristiche. Con la conquista araba (830 – 1071), anche il porto di Panormus divenne centro di gran parte del traffico tra i paesi arabi del Mediterraneo; fu in questo periodo che si ebbe la prima grande trasformazione del paesaggio portuale con la costruzione della cittadella fortificata (al Halisah, la Kalsa) a protezione delle strutture amministrative e militari esistenti.
All’inizio del XI secolo, il decadere della potenza musulmana ed il crescente pericolo delle flotte delle repubbliche marinare indussero gli Arabi a fortificare la città e a chiudere l’imboccatura del porto con una grossa catena (che partiva dalla Chiesa che prese appunto il nome “della Catena” in prossimità della Cala); nello stesso periodo venne costruito un forte a difesa del porto, il Castello a mare, presso l’odierno Molo Trapezoidale.

Con l’espugnazione della città ad opera dei Pisani nel 1064 e l’occupazione normanna, si assistette ad un’intensa attività portuale. Il progressivo interramento del porto, causato dai detriti riversati dai fiumi Kemonia e Papireto, ridussero sempre di più la superficie degli specchi acquei fino all’attuale configurazione della Cala. Si rese pertanto necessario costruire, nel 1575, il primo tratto del “Molo Sud”; l’anno successivo si diede inizio alla costruzione del Molo Nord, spostando così l’ambito portuale verso nord (attuale allocazione) e lasciando pian piano l’antico porto, la Cala, al naviglio minore. L’attuale porto di Palermo vide la sua nascita, per volontà del Viceré di Sicilia García Álvarez de Toledo y Osorio, essendo l’antico porto della Cala insufficiente e troppo angusto per le crescenti esigenze cittadine. Essendo il lato Sud della Cala occupato dalla passeggiata della marina, si scelse, come luogo di sviluppo per la nuova zona portuale, il lato Nord del centro abitato presso il nuovo quartiere di Santa Lucia (l’attuale Borgo Vecchio), fondato da Carlo d’Aragona Tagliavia nel 1570, che, proprio in funzione del porto, andò poi a sviluppare un carattere tipicamente marinaro.
Nel 1590, quando i lavori del Molo Nuovo furono ultimati, fu posto, all’ingresso del porto, un cippo in memoria dell’avvenuta costruzione. Il cippo, sormontato dall’aquila palermitana, presenta, su uno dei quattro lati, lo stemma del Viceré García de Toledo e, su un altro lato, la più antica raffigurazione esistente del Genio di Palermo.


L’area portuale andò sempre più espandendosi verso Nord, con la creazione, nel XIX secolo, dei cantieri navali, fino a raggiungere il porto dell’Acquasanta.
Nel corso del XIII secolo, il porto di Palermo era un vero e proprio gigante economico e culturale. Non solo fatturava più di tutta l’Inghilterra messa insieme, ma era anche il crocevia più importante al mondo per le merci e le comunicazioni. Questo porto siciliano era il cuore pulsante del Mediterraneo, un luogo dove si intrecciavano le rotte commerciali e si incontravano culture diverse.

La sua importanza storica è indiscutibile: Palermo era una città cosmopolita, un punto di incontro per mercanti e viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo conosciuto. Il suo porto, grazie alla posizione strategica e ai buoni fondali, era un attracco sicuro per le navi e un punto di partenza per le avventure marittime.

La ricchezza e la prosperità di Palermo in quel periodo sono testimoniati dalla sua architettura, dalle sue infrastrutture e dalla sua vivace vita culturale. Era un luogo dove l’arte e il commercio fiorivano fianco a fianco, e il suo porto era il simbolo di questa grandezza.

Un porto che ha fatto la storia, un’eredità che ancora oggi possiamo ammirare e che continua a influenzare la città di Palermo e il suo ruolo nel Mediterraneo. Nei secoli XVII e XVIII il grande porto di Palermo fu al centro dell’interesse dei mercanti europei, primi fra tutti olandesi e inglesi. Agl’inizi dell’’800 inizio si ebbe un ulteriore grande sviluppo dei traffici marittimi, si commerciavano vino, olio, carbone, legno, ferro, tele, cuoio, tabacco, farina, arance, formaggi, tonno, sale, zucchero. Nel 1839 il boom con 677 bastimenti con una esportazione totale di 2.356.168 tonnellate di merce, che fecero assumere al porto di Palermo un ruolo di prestigio a livello internazionale. Sul finire del XIX secolo le vicende del porto si legano al sorgere di una nuova classe di imprenditori ed armatori interessati al potenziamento e ammodernamento. E’ l’epoca dei Florio, della “Rubettino” e poi della Società di Navigazione Generale Italiana. Le vicende del porto si legarono al sorgere di una nuova classe imprenditoriale ed armatoriale che portò al suo ammodernamento e potenziamento; si deve ai Florio la nascita del grandioso cantiere navale, oggi gestito dalla Fincantieri, tra i più funzionali ed attrezzati d’Europa. Dopo l’Unità d’Italia, il porto di Palermo ha vissuto diverse fasi di sviluppo e cambiamento. Se durante il periodo borbonico, il porto era un importante centro commerciale e militare, con l’Unità d’Italia, l’attenzione economica e politica si spostò verso il nord del paese, in particolare verso Genova e Trieste, che divennero i principali porti italiani. Pur avendo una posizione strategica nel Mediterraneo, che lo avevano privilegiato per 2600 anni con l’avvento dell’unità d’italia le politiche economiche nazionali, gli investimenti disomogenei e la concorrenza con altri porti, con scelte politiche di industrializzazione e sviluppo infrastrutturale che hanno favorito il Nord, hanno ridimensionato l’importanza del ruolo del porto Palermo.
Dopo la seconda guerra mondiale i bombardamenti lasciarono un porto con moli e banchine distrutte; iniziarono cosi i lavori di ricostruzione ed il riammodernamento strutturale promossi dall’allora Ente Autonomo del Porto.
L’area portuale andò sempre più espandendosi verso Nord, con la creazione, nel XIX secolo, dei cantieri navali, fino a raggiungere il porto dell’Acquasanta.
Nel corso del XIII secolo, il porto di Palermo era un vero e proprio gigante economico e culturale. Non solo fatturava più di tutta l’Inghilterra messa insieme, ma era anche il crocevia più importante al mondo per le merci e le comunicazioni. Questo porto siciliano era il cuore pulsante del Mediterraneo, un luogo dove si intrecciavano le rotte commerciali e si incontravano culture diverse.
La sua importanza storica è indiscutibile: Palermo era una città cosmopolita, un punto di incontro per mercanti e viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo conosciuto. Il suo porto, grazie alla posizione strategica e ai buoni fondali, era un attracco sicuro per le navi e un punto di partenza per le avventure marittime.
La ricchezza e la prosperità di Palermo in quel periodo sono testimoniati dalla sua architettura, dalle sue infrastrutture e dalla sua vivace vita culturale. Era un luogo dove l’arte e il commercio fiorivano fianco a fianco, e il suo porto era il simbolo di questa grandezza.
Un porto che ha fatto la storia, un’eredità che ancora oggi possiamo ammirare e che continua a influenzare la città di Palermo e il suo ruolo nel Mediterraneo. Nei secoli XVII e XVIII il grande porto di Palermo fu al centro dell’interesse dei mercanti europei, primi fra tutti olandesi e inglesi. Agl’inizi dell’’800 inizio si ebbe un ulteriore grande sviluppo dei traffici marittimi, si commerciavano vino, olio, carbone, legno, ferro, tele, cuoio, tabacco, farina, arance, formaggi, tonno, sale, zucchero. Nel 1839 il boom con 677 bastimenti con una esportazione totale di 2.356.168 tonnellate di merce, che fecero assumere al porto di Palermo un ruolo di prestigio a livello internazionale. Sul finire del XIX secolo le vicende del porto si legano al sorgere di una nuova classe di imprenditori ed armatori interessati al potenziamento e ammodernamento. E’ l’epoca dei Florio, della “Rubettino” e poi della Società di Navigazione Generale Italiana. Le vicende del porto si legarono al sorgere di una nuova classe imprenditoriale ed armatoriale che portò al suo ammodernamento e potenziamento; si deve ai Florio la nascita del grandioso cantiere navale, oggi gestito dalla Fincantieri, tra i più funzionali ed attrezzati d’Europa. Dopo l’Unità d’Italia, il porto di Palermo ha vissuto diverse fasi di sviluppo e cambiamento. Se durante il periodo borbonico, il porto era un importante centro commerciale e militare, con l’Unità d’Italia, l’attenzione economica e politica si spostò verso il nord del paese, in particolare verso Genova e Trieste, che divennero i principali porti italiani. Pur avendo una posizione strategica nel Mediterraneo, che lo avevano privilegiato per 2600 anni con l’avvento dell’unità d’italia le politiche economiche nazionali, gli investimenti disomogenei e la concorrenza con altri porti, con scelte politiche di industrializzazione e sviluppo infrastrutturale che hanno favorito il Nord, hanno ridimensionato l’importanza del ruolo del porto Palermo.
Dopo la seconda guerra mondiale i bombardamenti lasciarono un porto con moli e banchine distrutte; iniziarono cosi i lavori di ricostruzione ed il riammodernamento strutturale promossi dall’allora Ente Autonomo del Porto.
