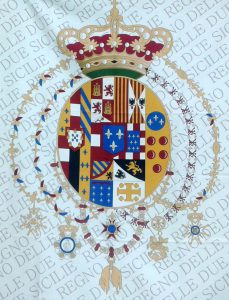A Napoli la stessa cultura meridionalista ha ignorato sistematicamente il mare, non lo ha vissuto come risorsa, non lo ha rivendicato come diritto. Però è un fatto che fino a tutto il Settecento e oltre la flotta borbonica fu seconda soltanto a quella inglese. Qualche raro libro di storia racconta la passione di re Ferdinando per la navigazione a vapore allora ai suoi esordi. Sempre il medesimo Ferdinando, fanatico della propulsione a vapore, istituì a Pietrarsa il Real Opificio Meccanico Militare che fu la prima scuola di ingegneri meccanici d’Italia. (Ermanno Rea, Napoli Ferrovia, 2007).
La marina napoletana nei primi anni del regno di Carlo III era definita “povera”, la “navigazione né mari del nostro regno facevasi con legni stranieri in difetto dè nazionali” (L. Bianchini). Per questo anche il commercio languiva, i porti erano chiusi e per l’esportazione ci volevano dei permessi speciali che erano difficili da ottenere. Ma sia Carlo III che Ferdinando IV, capirono che solo con una moderna marineria mercantile e militare si poteva migliorare il commercio. Grazie al ministro Acton si creò una flotta navale che nel 1793 era la maggiore di tutti gli stati italiani, fù ingrandito e riadattato il porto di Napoli, si costruirono arsenali, si fondarono scuole nautiche. Bisogna ricordare però che molte difficoltà incontravano le navi mercantili, che dovevano quasi sempre essere scortate da navi militari, perché i pirati barbareschi, francesi e successivamente greci infestavano le coste predando i mercantili fino all’imboccatura dei porti. Dal Regno di Napoli si potevano esportare prodotti e manufatti gran parte dei quali godevano dello smercio nel Levante come i ricami e i preziosi galloni, le pannerie e le seterie, le telerie, la carta, i coralli, le terraglie, i vini, lo zolfo, la cenere di soda, i frutti secchi, la pasta, i legnami, l’olio, il lino ed altro ancora. Dal Levante i mercanti napoletani potevano importare quei generi che più gli conveniva come ogni sorta di droga, l’avorio, il caffè moka, ed ogni sorta di commestibile, carbon fossile e vari minerali, e li avrebbero avuti così di prima mano senza dover ricorrere ad altre piazze d’Italia o di Francia, come fino all’ora avevano fatto, acquistandoli tutti di seconda e terza mano. Inoltre avendo l’Egitto riaperte le relazioni con l’India e la Cina per mezzo del Mar Rosso, sui mercati del Cairo e di Alessandria si potevano acquistare i prodotti importati dall’Oriente come pepe, zenzero, zuccheri, telerie, mussolina di cotone, ami, Cassia lignea, cannella, rabarbaro, thè, macchine, ed ogni sorta di manifattura cinese ed altro. Aprendo i maggiori porti napoletani al transito delle merci, osservava Riccardo Fantozzi, si sarebbe avuta la ricorrenza generale non solo dei bastimenti nazionali ma anche degli Esteri, i quali invitati non solo dalla felice situazione centrale del Mediterraneo e delle piazze di Napoli e di Messina, ma anche dal porto franco e di dogana di transito, non mancherebbero di approdarvi sia per prendere notizie commerciali, quanto per scaricarne le loro mercanzie da tale traffico e lascerebbe così la formazione di depositi indette due piazze ponendolo in condizione di provvedere ad altre nazioni. La felice situazione geografica del Regno delle Due Sicilie, centrale del Mediterraneo, voleva il porto di Napoli e non solo di poter primeggiare nel commercio del Levante sopra tutte le altre nazioni europee, ma anche di gareggiare con le maggiori città commerciali della Grecia e degli altri stati italiani, della Francia e della Spagna. Ma per fare ciò bisognava dare un nuovo impulso ed occorreva eliminare gli ostacoli che si frapponevano. Così il console napoletano in Egitto, R. Fantozzi, aveva avuto uno scambio di vedute con il pashà Mohamed Ali sul modo di aprire delle relazioni dirette di Commercio appunto fra l’Egitto e il Regno di Napoli, e sulla possibilità di concedere ai napoletani il libero transito per l’Egitto delle merci che avrebbero voluto importare dall’India. Il viceré espresso il suo gradimento al Fantozzi, e per dare un incoraggiamento al suo progetto sarebbe stato il primo a spedire a Napoli quei carichi che gli sarebbero stati indicati, assicurando poi la massima protezione al commercio di transito con l’India e favorendo i mercanti napoletani che non avrebbero pagato più di quello che pagavano gli inglesi sui diritti e avrebbero goduto degli stessi privilegi. Arrivato a Napoli il progetto del Fantozzi veniva trasmesso dal ministero degli Esteri a quello degli Interni.
Nel 1818 il governo borbonico, contrariamente a quanto avveniva in altri stati europei, aveva imboccato la strada di una politica doganale ispirata a criteri piuttosto liberistici. Si sopprimevano le dogane “baronali” che dipendevano ora solo dalla Gran Dogana della Capitale, che istituì una scala franca per le navi e le merci provenienti dall’estero. Si approvò un “codice di commercio” regolato dal Ministero della Marina, e a Napoli venne istituita la direzione generale per la navigazione (a cui dipendevano 10 commissioni marittime: Napoli, Gaeta, Salerno, Amantea, Pizzo, Gallipoli, Barletta, Manfredonia, Pescara e Giulianova. Per la Sicilia Palermo, che dipendeva da Napoli, Catania, Messina, Siracusa, Girgenti, e Trapani. Controllavano il movimento delle navi nei porti, riscuotevano i dazi ed esplicavano varie formalità.) che rendeva conto al ministero della marina e a quello delle finanze. Questo richiamò nel Regno un gran numero di commercianti, industriali e banchieri stranieri. Così, mentre la maggior parte dei governi europei attuava una politica doganale protettrice delle industrie nazionali, il governo borbonico proseguiva una politica liberista. Dal 1817 si favorì l’importazione di merci straniere con un dazio che non superava il 3%, solo poche merci raggiungevano il 25%. Ciò aggravò però un ristagno dei prodotti nazionali e così su alcuni prodotti fu attuata nel 1823 una politica più protezionistica. Si mantenne una tassa del 3% sulle merci grezze mentre si aumentò al 30% su quelle lavorate, ma le merci che viaggiavano sulle navi napoletane venne ridotto il dazio. Si istituì il porto franco a Messina e si stabilì che il cabotaggio lungo le coste dei reali domini di qua e di là del faro fosse libero ed immune da qualsiasi formalità e pagamento. Queste nuove tariffe contribuirono ad alleviare gli ostacoli che si contrapponevano al commercio estero con il regno e a stimolare la nascita di una borghesia commerciale ed industriale. Il 16 ottobre 1827 si stipulò una convenzione tra il Regno delle Due Sicilie e Costantinopoli per il libero passaggio delle navi napoletane nel mar Nero. Il Regno di Napoli, nel periodo che va dal 1830 al 1860 superò la crisi economica causata dalle vicende del governo napoleonico e dalla Restaurazione. Tale progresso era dovuto al formarsi una nuova borghesia agiata sorta gli inizi del secolo e irrobustitasi negli anni successivi. Si trattava di borghesi agiati, avvocati, notai, medici, affittuari che disponevano di capitali facendo largo ad una borghesia industriale e commerciale che cominciò a sorgere col blocco continentale che stimolò lo sviluppo di alcune industrie, come quelle del cotone e della lana e si diffuse ancora più dopo il 1824 con la protezione doganale accordata alle industrie del Regno ed in particolare a quella della stoffa, della seta, della carta, dei tessuti di cotone, della canapa, del lino e dei panni di lana. Si diede così impulso all’attività industriale la quale migliorò grazie ai capitali stranieri, svizzeri e tedeschi, che cominciarono ad affluire nel regno.
Si costituirono alcune società come la società enologica, la società industriale partenopea, la società per la navigazione a vapore, ed una rete di società economiche che si adoperarono per migliorare le condizioni economiche del paese. L’esportazione della seta grezza consentita nel 1824, invogliò la cultura del gelso e l’allevamento del baco e i 2/3 di tale produzione (1.200.000 libbre) veniva esportato negli Stati Uniti. La produzione di seta napoletana soddisfaceva tutti i bisogni interni tanto da sospenderne l’importazione dall’estero. Manifatture di seta sorgevano in diverse province del regno e Catanzaro era da considerarsi il centro di tale manifatture, dove nel 1845 si contavano 19 case con 52 telai. Altre sorgevano a Napoli, Reggio, Monteleone, Matera, Cosenza, Trapani, Messina e Palermo. I Rasi ed i velluti del grandioso” stabilimento di San Leucio a Caserta, avevano una fama universale. Nel 1835 a Napoli, ad Isola del Liri e ad Arpino sorgevano fabbriche di tessuti di lana bene attrezzate che davano un’eccellente produzione e facevano largo uso della materia prima locale, tanto che l’esportazione della lana grezza aumentò e ne diminuì la sua importazione. Molte industrie del cotone erano sorte in Campania, in Calabria, in Abruzzo ed in Sicilia e lavoravano ogni genere di tessuto, potendo gareggiare con i prodotti svizzeri francesi e inglesi. Avevano introdotto la forza motrice del vapore nella filatura e nella tessitura, e i macchinari Inglesi e svizzeri per i fusi erano aumentati tanto che nel 1840 ve ne erano 30.000 e producevano 2 milioni di libbre di filati, impiegando ben 60.300 operai! Notevole fu anche lo sviluppo dell’industria della carta e in dieci anni dalla quasi totale importazione del fabbisogno interno si arrivò all’esportazione in molti paesi europei, nel levante e in Brasile. Buoni furono i progressi dell’industria meccanica che nel 1859 contava 100 opifici e 12.000 operai. In agricoltura le reali società economiche (erano sorte già dal 1810 come società di agricoltura) si erano adoperate molto per diffondere i nuovi metodi di coltivazione e per incoraggiare l’introduzione dell’avvicendamento agrario per fare abbandonare l’antico sistema di riposo della terra avevano acquistato macchine e avevano importato semi e piante per sperimentare l’andamento di nuove culture, diffondevano nozioni utili sulla qualità dei terreni e promuovevano l’uso dei concimi minerali e nuovi metodi per la cura delle malattie delle piante, stabilendo premi di incoraggiamento per coloro avessero ottenuto una maggiore produzione o introdotti nei propri campi macchine e nuovi metodi di coltivazione. Questi sforzi iniziavano a dirottare le menti dei proprietari terrieri e di alcuni contadini. La produzione del grano crebbe di molto a confronto dell’inizio del secolo, tanto che la maggioranza della popolazione mangiava pane di grano e ciò non accadeva in tutta la penisola! La produzione cerealicola e del granturco era divenuta la più alta di molti stati preunitari ed anche la produzione di olio aumentò grazie all’estensione delle colture e al miglioramento dei metodi di raccolta e molitura delle olive. La produzione di vino venne quadruplicata, si coltivò il cotone che era molto richiesto dalle industrie. Larga era l’esportazione di agrumi specie dalla Sicilia verso i paesi nordici ricercati per le proprietà antiscorbutiche. Dopo il 1845 si abbandonò la politica protezionistica e si intensificarono le relazioni commerciali con l’estero, stipulando trattati con Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia, Belgio, Austria, Danimarca, Prussia, Sardegna, Paesi bassi e Impero ottomano. Furono emanati tre decreti che riducevano le tasse sui prodotti di importazione, con riduzioni tra il 15 e il 60%. Ed ancora meglio fece Francesco II che a marzo del 1860 ridusse i dazi fino al 70% su molti generi di consumo e materie prime. La marina mercantile raddoppiò il numero dei legni con nuove navi ad elica che erano “atti grandemente al trasporto delle merci in brevissimo tempo e quindi con tenui noli” (L. Bianchini). Il governo contribuì a tale sviluppo migliorando porti e fari, fondando scuole nautiche e favorendo la costituzione di compagnie di assicurazione marittime.
La politica economica del Regno per molti storici ed economisti è vista solo come protezionistica e fine a se stessa, ma in realtà era da supporto ad una identità nazionale in campo economico necessaria per favorire un fattore di prosperità della nazione, necessaria visti anche i progressi che venivano attuati in altri paesi. (A. Lepre).
Ma i fasti del Settecento e dell’Ottocento sono ormai solo un ricordo, l’unità della penisola avvierà una decadenza post- unitaria per la marina mercantile, per i cantieri navali, per il Porto di Napoli e tutti i porti del Regno, per i traffici , per il commercio, per le industrie e per la stessa agricoltura nulla sarà più come prima: l’economia che lentamente si stabilizzava verso un futuro di floridità viene annegata in quel mare che come dice Rea non verrà più visto come una grande risorsa.

Con la realizzazione ella Litoranea, il compimento della colmata di Santa Lucia, il prolungamento di via Caracciolo e l’allargamento di via Posillipo, anche il litorale occidentale diventa parte dell’intervento che, in continuità con quelli ottocenteschi, modificherà definitivamente la naturale linea di costa. Non più spiagge, caseggiati o costoni tufacei, da Posillipo fino al Piliero, un ampio e continuo solco viario separa il tessuto urbano dalle acque del Golfo e definisce il margine della città sul mare.

L’enorme quantità di naviglio nel porto del Piliero sulla omonima via.