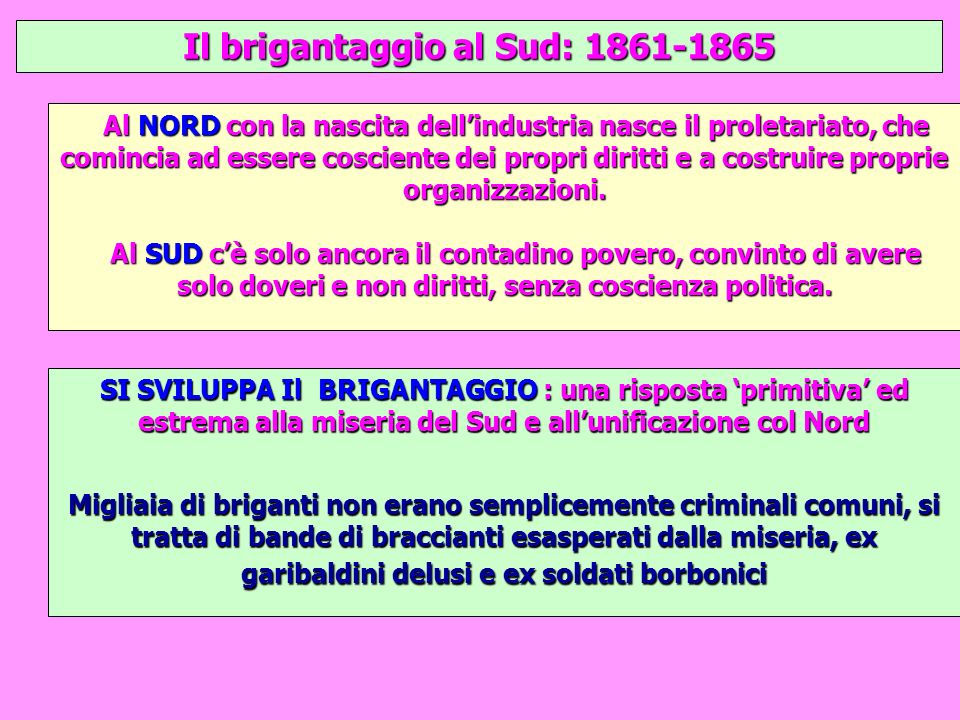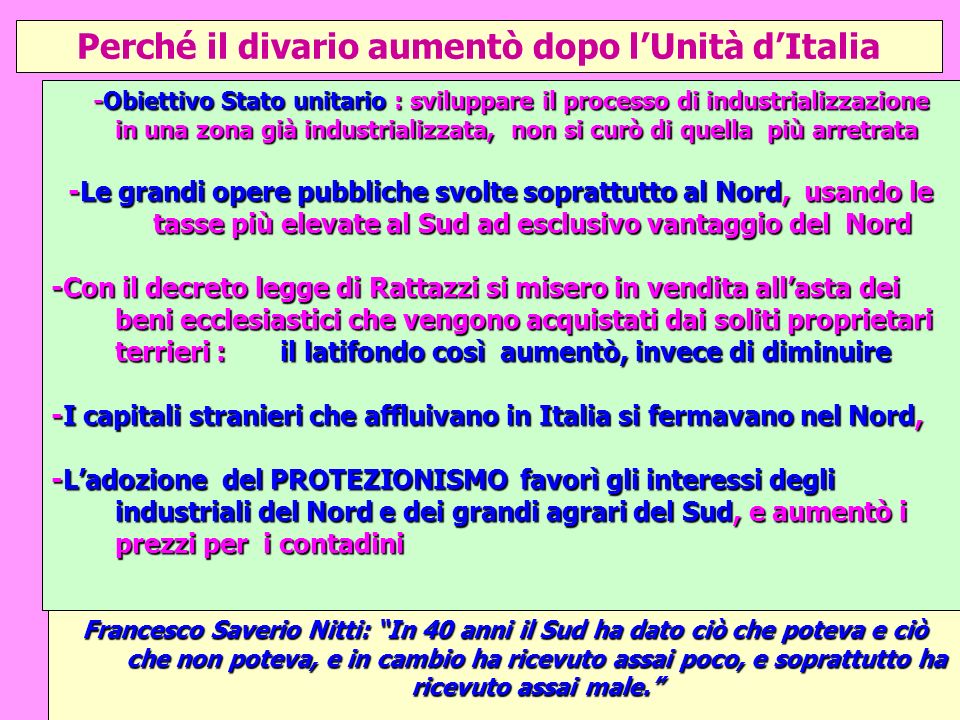Cos’hanno in comune la Sardegna del 1720 e del 1847; il Regno delle Due Sicilie del 1860-61 e il Mezzogiorno di oggi; la Germania Est del 1989 e di adesso; la Grecia e altri paesi dell’UE, Italia inclusa, sottoposti a cure da cavallo (o eutanasia…) dalla Germania; e persino l’intera Europa rispetto al resto del mondo? Sono Sud di Nord sempre più grandi; costretti in stato di minorità con sistemi che, anche quando non riconoscibili come tali nella forma, rimangono gli stessi nella sostanza, pur al procedere dei secoli e al mutare di regimi e tecnologie. Ogni volta, però, studiati come nuovi, nonostante tutto sia già stato fatto, visto, detto, e ignorato. All’origine, ufficialmente mossi dalle migliori intenzioni, c’è l’intento di distruggere qualcosa, per sostituirlo con altro, di meglio (per chi lo fa, non per chi lo subisce). Poi si scoprirà che quello (o molto di quello) che si è distrutto non meritava di esserlo e la sostituzione con qualcosa di meglio rimane un’intenzione, chissà se mai davvero esistita. Un cammino, così, viene interrotto; se pur si volesse riprenderlo, la distanza fra chi ha imposto la frenata per approfittarne, e chi è stato frenato, cresce. E continuerà a farlo, finché non intervenga una volontà (credibile e condivisa) di colmarla. La volontà di stare insieme alla pari. Con il disconoscimento di diritti già goduti e l’esclusione «dell’elemento indigeno» da «ogni partecipazione alla vita pubblica» (e dall’economia, se non in ruoli gregari), «si creava una colonia» scrive il magistrato e senatore Giuseppe Musio nel 1875, storico della sua Sardegna, prima annessa al Piemonte, poi italiana. Le stesse parole ritroveremo, come copiate, nei testi di tanti autori che si sono occupati della riduzione a colonia dell’ex Regno delle Due Sicilie; poi, nelle analisi sulla Germania Est oggi e, infine, su cosa rischia l’Europa mediterranea per l’uso spregiudicato del super-euro da parte dei tedeschi, con l’appoggio sempre meno convinto della Francia che, non potendo impedire alla Germania di fare, preferisce aiutarla a fare (i francesi si sentono vittime ricorrenti dell’imperialismo tedesco per le invasioni subite, ma dimenticano che le guerre napoleoniche fecero circa tre milioni di morti, di cui una parte rilevante tedeschi, quando l’Europa aveva 165 milioni di abitanti, scrive Guillaume Duval in Made in Germany. Le modèle allemand au-delà des mythes). L’accostamento fra le vicende storiche e attuali dell’Italia e della Germania, su questi temi, è obbligato: sono molto simili, perché figlie di un’idea di stato-nazione che ebbe la sua prima teorizzazione al mondo con il Risorgimento italiano e i suoi sviluppi (tanto da essere preso a esempio). Come ricordano gli storici, l’esaltazione del concetto di stato- nazione portò al nazionalismo e alle avventure coloniali, imperialiste; e poi, degenerando, al nazional-socialismo. Da noi cominciò nel 1720: la Sardegna fu ridotta a «una fattoria del Piemonte». E nacque la Questione sarda. L’isola subì tali spoliazioni, che ancora agli inizi degli anni Cinquanta del Novecento era «la meno coltivata e la più disboscata regione d’Italia» riferisce Sandro Ruju nel volume monografico della Storia d’Italia di Einaudi. Industria e ricca agricoltura specializzata del Regno delle Due Sicilie, circa un secolo e mezzo dopo, furono sacrificate allo sviluppo del Nord. E fu la Questione Meridionale. Nella Germania Est (in cui il paese riunificato, per infrastrutture e sussidi alla popolazione, ha comunque riversato una quantità impressionante di denaro), dopo la caduta del muro di Berlino, si è arrivati a “sperpero e distruzione di risorse senza confronti in tempo di pace”. E ora hanno la Questione orientale. Tanto che la Germania Est è oggi l’ex paese del blocco orientale con la peggiore economia, mentre era il primo. È anche l’unico degli ex satelliti dell’Unione Sovietica in cui proprio l’incontro con la più potente economia d’Europa ha comportato l’azzeramento sia del sistema produttivo che dell’intera classe dirigente (in nessuno degli altri è successo altrettanto). Il caso della Germania Est, porta a riflessioni nuove: la rappresentazione e la causa del ritardo degli altri “Sud”, a partire dal nostro Mezzogiorno, sono indicate nella carenza di infrastrutture e servizi (dai trasporti alla sanità, all’istruzione) di cui è dotato, invece, il resto del paese. Be’, questo non si può dire dei Länder (regioni) orientali tedeschi, eppure essi sono indiscutibilmente “Sud”. Significa che sbaglia chi pensa si risolva il problema solo dando ai territori svantaggiati le stesse condizioni di efficienza degli altri. È evidente che questo ci vuole, ma non basta, senza la volontà di essere pari. I “compiti a casa” assegnati dai paesi forti dell’Unione Europea ai più deboli, per fronteggiare la crisi economica, hanno aggravato i guai invece di risolverli (che fosse proprio questo il risultato voluto?): i “tagli” per risparmiare hanno frenato l’economia, acuito la crisi, ridotto lavoro, produzione ed entrate fiscali e accresciuto i costi per l’aumento della disoccupazione. Giusto il contrario di quanto ci si proponeva. E questo ha così tanto inasprito le tensioni fra paesi del Sud e del Nord che alcuni si domandano se abbia ancora senso restare nell’euro, la moneta comune, o nell’Unione. Generando la Questione europea. L’unificazione violenta delle economie, dalla Sardegna che diviene piemontese all’Europa di oggi (alle Due Sicilie, si fece pure guerra), ha creato divari che crescono con il tempo (alla vigilia dell’Unità, dopo circa 130 anni di governo sabaudo, in Sardegna, tolti possidenti e pensionati, i “senza professione” erano 330.000: più della metà della popolazione e quasi il doppio di quelli che ne avevano una: minatore, pastore, artigiano…). La cosa è ben più evidente nel caso della Germania Est e dell’Europa meridionalizzata. Si è ricorsi alla moneta unica, per rendere senza ritorno il ricongiungimento fra tedeschi dell’Ovest e dell’Est e la permanenza nell’Unione Europea di una Germania ormai troppo grande e ricca per lasciarla sola e incontrollata. Il marco occidentale fu equiparato a quello orientale, che valeva quattro volte e mezzo meno; poi si varò l’euro, specie per pressione della Francia, che nella moneta comune vedeva sparire il primato del marco sul franco (illusorio successo fotografato dal folgorante e citatissimo commento dello storico inglese Geoffrey Garrett: «Una Germania intera per Kohl, mezzo marco per Mitterrand»). L’unificazione monetaria dell’Europa precedeva quella politica per accelerarla, forzarla. Insomma, come far sposare al tuo erede la figlia del tuo socio: intanto si rafforza l’azienda; l’amore poi verrà… Dalla Sardegna al continente, dal Settecento al Duemila, si ripropongono fenomeni economici e sociali incredibilmente simili (cambiano solo le dimensioni): si crea un divario, poi se ne addossa la colpa a chi l’ha subito; si impedisce uno sviluppo autonomo, il che indebolisce capacità e volontà, sino all’apatia; l’emigrazione, lo svuotamento dei paesi; il risentimento, la protesta, donde le accuse di vittimismo; la rassegnazione e la rinuncia, sino alla denatalità: i giovani non si sposano e, se sì, non fanno figli. Nel caso del Mezzogiorno, nel 2012, per la terza volta in un secolo e mezzo, si è avuto un saldo demografico negativo: più i morti dei nati. Era già accaduto nel 1867, ma c’erano stati i massacri e i saccheggi compiuti dai “fratelli d’Italia” (conoscete la storia di Caino?) ed era ancora in corso la guerra civile contro i “briganti” che si opponevano a un esercito invasore. (Naturalmente la causa del crollo di popolazione al Sud non furono le stragi, i furti, «l’instaurazione di un vero e proprio regno del terrore», come fu denunciato in Parlamento a Londra, rammenta Paolo Mieli, in “I conti con la storia”, ma il fatto che i meridionali, incuriositi dall’arrivo di un esercito, si distrassero e trascurarono le loro donne: «Scusate, ma che state facendo?», «On va faire l’Italie». Poi, qualcuno deve aver detto: «Fate l’amore non fate la guerra». Un altro saldo demografico negativo si era avuto dopo la Prima guerra mondiale, nel 1918, ma in seguito alla spaventosa “influenza spagnola” (in realtà portata da soldati statunitensi) che fece 50 milioni di vittime nel mondo ed è ritenuta la più assassina pandemia della storia dell’umanità. Qualche domanda ci vuole, se gli stessi risultati, al Sud, li abbiamo avuti in seguito a vent’anni di Lega Nord e al modo in cui è stata fatta l’Unità (e pensare che nel secolo precedente, il Regno delle Due Sicilie aveva più che raddoppiato la popolazione in pochi anni; ma con una «crescita», scrive in “Borbonia felix” Renata De Lorenzo, docente di storia, «di tipo russo, orientale o balcanico», !?; mentre se a crescere è la popolazione del Centro-Nord, «è evidente il nesso tra demografia e vita civile». I meridionali non hanno ancora pagato il debito di gratitudine per il sopraggiunto metodo sabaudo, occidentale, massonico di controllo delle nascite. Erano abituati ad altri, più divertenti ma meno sicuri…. Quello che succede oggi nel nostro Sud accade contemporaneamente nella Germania Est, dove, con un sesto della popolazione, si concentra metà della disoccupazione (prima inesistente) di tutto il paese; la quantità di case vuote e sfitte a causa dell’emigrazione a Ovest è tale che, per fermare il crollo dei prezzi oltre limiti tollerabili, meno di dieci anni dopo la caduta del muro, si era già deciso di abbattere 350.000 abitazioni. Né mai, in tempo di pace, le nascite erano scese tanto fra i tedeschi dell’Est; ci fu qualcosa di paragonabile solo con la Prima guerra mondiale. C’è «una costante diminuzione della popolazione delle regioni dell’Est a partire dal momento dell’unificazione» ricordano gli economisti Nicola Coniglio, Francesco Prota e Gianfranco Viesti in Note sui processi di convergenza regionale in Germania e Spagna: si è passati da 1,52 figli a donna, a 0,77 nel 1994, il «livello più basso di sempre». Ed è dovuto soprattutto al fatto che a emigrare dai Länder orientali sono principalmente donne (55 per cento), giovani (dai 18 ai 29 anni), altamente qualificate. In una parola: il futuro. Sembra un bollettino di guerra: il vincitore si prende i beni, le donne, la gioventù e il futuro del vinto. E la chiamano Unità. Se guardiamo poi, non a un paese o due, ma a tutta l’Europa unita, osserviamo gli stessi fenomeni. Quando in Sardegna furono imposte analoghe politiche economiche egoiste e di rapina, si ebbero rivolte, proteste, tacitate con la violenza, gli stati d’assedio e condanne a morte di cui il Piemonte è sempre stato generoso. Risultati? Nell’isola non si è mai sopita una vena indipendentista che s’ingrossa nei periodi più aspri. Nell’ex Regno delle Due Sicilie si ebbe un’opposizione in armi, per circa dieci anni: fu schiacciata; e oggi affiorano, via via più forti e convinti, propositi autonomisti. Nella Germania Est rimpiangono addirittura il muro! Nell’Europa unita, i paesi più stressati da fragilità economica e instabilità politica e dall’aggressiva strategia mercantilista della Germania cominciano a pensare che se questo è stare insieme, forse meglio soli. E fanno conti per vedere se non convenga uscire dalla moneta comune. Il che si ritorcerebbe contro la stessa Germania: la sua economia è sbilanciata sulle esportazioni, che crollerebbero, perché i concorrenti, svalutando la propria moneta, abbatterebbero i prezzi, mentre i tedeschi, con un euro ancora più forte, non potrebbero fare altrettanto. L’egoismo, però, se è vero che alla lunga non paga, nell’immediato rende. La storia è maestra, insegna a sbagliare. Con la caduta del muro di Berlino, scomparvero, da un giorno all’altro, gli analisti politici più sofisticati e meglio pagati del pianeta: i sovietologi, capaci di elaborare teorie e previsioni complicatissime da segnali minimi, non visibili da occhio profano. Mentre, pure in conseguenza di quel crollo, hanno ripreso vigore i cultori di una delle più complesse dottrine politico-sociali, il meridionalismo, nato in Italia e ora importato nel Nord del continente, per cercare di capire la Germania Est di oggi e l’Europa di domani (c’è una circostanza dimenticata che accomuna terroni e tedeschi orientali: ai primi fu fatto pagare, dal Piemonte, con una tassa speciale, il costo dell’invasione subita; e solo sui tedeschi dell’Est restò l’obbligo di pagare all’Unione Sovietica i danni di guerra cui era stata condannata la Germania nazista, avendo quella occidentale versato quasi nulla. Vizietto teutonico: neanche dopo la Prima guerra mondiale i tedeschi pagarono i debiti e, pur ergendosi oggi a feroce guardiana del patto di stabilità dell’Unione Europea che impedisce di sforare di più del 3 per cento il bilancio nazionale, la Germania rifiutò di pagare la sanzione prevista, quando fu lei a farlo. Così, oggi, nel tentativo di capire la Germania dell’Est, i tedeschi studiano la nostra Questione meridionale. Ma, nonostante questo, è proprio da quanto hanno fatto, dopo l’unificazione, nelle loro regioni orientali, che i tedeschi (si intende dell’Ovest, pur se a capo del governo c’è una dell’Est) traggono il metodo per agire nell’Unione Europea. Essi «hanno cominciato a trasferire sull’Europa in crisi le “verità” conquistate durante la riunificazione» scrive il sociologo Ulrich Beck, docente alla London School of Economics, in Europa tedesca. La nuova geografia del potere. E quali erano queste verità? Che quelli dell’Ovest, i Wessis, erano più bravi in tutto e per aggiustare l’Est bisognava sostituire i connazionali orientali ai posti di comando, in ogni campo, e rimpiazzare tutto quello che era dell’Est con l’analogo dell’Ovest: la geografia come soluzione. E così si sta comportando la Germania con i paesi debitori, in Europa, non sostituendosi ai capi (non può, almeno per ora…), ma obbligandoli a politiche, regole, “compiti a casa”. Con lo stesso “atteggiamento imperiale” usato con la Germania Est. «In altre parole», riassume Beck, è quello «il modello della politica tedesca di crisi in Europa.» . Ovvero quello che creò la Questione sarda, poi la Questione meridionale, poi la Questione orientale tedesca; e oggi la Questione europea: ancora un Nord e un Sud, ma sempre più grandi. Detto questo, ricordiamoci pure che veniamo da un passato molto peggiore. La Sardegna fu il primo Sud, per la fusione con lo «stato peggio governato d’Italia» scrisse il filosofo e deputato Giovanni Battista Tuveri: nacque così «il primo rapporto tra Nord e Sud in uno stato dell’Italia moderna» aggiunse Franco Venturi; e quel che fu fatto all’isola fece scuola, divenne metodo: il modo dell’Italia di essere paese. La Questione meridionale fu l’estensione al Mezzogiorno continentale del sistema economico (e politica conseguente) che la dinastia sabauda aveva adottato con l’isola: la trattava come una colonia, a cui dava poco e da cui prendeva persino la dignità regale, perché mentre la Sardegna era un regno, gli altri stati sardi “di terraferma”, con essa prima confederati e poi “fusi”, erano solo un insieme di enti minori: il Principato del Piemonte, i Ducati di Savoia, d’Aosta, di Monferrato, di Genova (ex repubblica), parte di quello di Milano, il Marchesato di Saluzzo, i Feudi delle Langhe e del Canavese, la Signoria di Vercelli, i Contadi di Nizza e di Asti (riporto da Nuovi elementi di Geografia, del 1850, citato dal professor Francesco Cesare Casùla in Italia. Il grande inganno 1861-2011). Ma alla Sardegna non piace essere Sud (anche i sardi «hanno sofferto e soffrono di pregiudizi largamente accostabili a quelli di tutto il Sud» scrive il professor Antonino De Francesco, in La palla al piede), ritenendo di essere una cosa e una storia a parte: al più, assimilabile al Centro, per latitudine (ma trattasi di illusione ottica, perché Olbia è alla stessa altezza di Barletta e Cagliari a quella di Catanzaro); per percorsi comuni (con la Toscana e Pisa, in particolare, che a lungo signoreggiò in una larga fetta dell’isola); e anche ritenendosi, molti sardi, più simili al Nord, per la storia condivisa prima con la Liguria (Genova concorreva con Pisa nell’infeudarsi l’isola) e poi con il Piemonte; ma soprattutto per alcune “specificità” (parola a cui tengono molto) e comportamenti che li distinguono dal Mezzogiorno, in scelte di modernità (l’elevata percentuale di votanti favorevoli al divorzio; quella, molto alta, dei matrimoni civili; o la partecipazione ad attività di volontariato, superiore alla media italiana, molto superiore a quella del Sud). Ma pure nell’isola i sardi vedono un Sud e un Nord sia geografico che sociale, economico, specie per l’approdo del turismo ricco ed elitario, non soltanto in Costa Smeralda (a Olbia, sentendosi settentrionali rispetto ai cagliaritani, in qualche tornata elettorale alla Lega Nord hanno dato percentuali a due cifre); e la stessa diversità ravvisano fra il litorale e l’interno: il primo più evoluto, aperto, ricco, per via della maggiore facilità di contatti e scambi con il continente; il secondo più antico (e, nel desiderio e nell’attesa dei turisti, persino “arcaico”: e così glielo offrono, rifatto per forestieri e telecamere), custode severo dei costumi, dell’essere e del pensare isolano. Tanto che si dice “Sardegna italiana” di quella costiera, e “Sardegna sarda” di quella interna (più o meno la distinzione che c’era fra Romanìa e Barbarìa, quando l’occupazione romana dell’isola costrinse a rifugiarsi nelle più aspre zone lontano dal mare). Tutta insieme, però, la Sardegna è indubitabilmente Sud. Lo è stata molto prima e molto più del Mezzogiorno continentale, ma si è visto meno. E, per i dati economici pesanti, le infrastrutture scarse, il tipo di industrializzazione che (come a Taranto, a Gela, ad Augusta e altrove) usa l’isola, la svuota, la sporca e l’abbandona, dopo una breve illusione di uscita da un ritardo plurisecolare, la Sardegna rientra a pieno titolo nella Questione meridionale. Nel caso dell’isola, non ci fu bisogno di crearne le condizioni, ma solo di peggiorarle con un’economia da rapina che ne impedì una ripresa autonoma, anche quando la si tentò. Per il Sud continentale fu necessario prima conservare quel che c’era di storto e malfatto; poi spezzare le spighe alte e gonfie, perché il campo ne offrisse solo di basse e magre, per accusare il contadino di incapacità. È un sistema adottato da sempre (Erodoto racconta che lo consigliò Trasibulo, tiranno di Mileto, a Periandro, tiranno di Corinto), ma si fa fatica a riconoscerlo, perché viene nascosto dietro cattiva informazione e dettagli strillati che oscurano il totale. Mentre i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri (vale che si parli di persone o di paesi), la responsabilità viene pubblicamente addossata ai più poveri, ovvero a chi ha meno potere per incidere su quel che accade e non governa i mezzi di comunicazione, per raccontare un’altra verità. Che ne dite, per esempio, di “i greci sono pigri” (lavorano più di duemila ore all’anno; i tedeschi meno di 1.400); o “classi dirigenti locali”, che sono “dirigenti” solo perché eseguono (guadagnandoci, si capisce) politiche e voleri di quelle centrali? La Germania Est, per dire: caduto il muro di Berlino, lo stato fratello dell’Ovest condusse l’unificazione in modo così violento ed egoista da azzerare completamente la potenza industriale dell’Est (molta era di discutibile solidità, ma in alcuni comparti era fra le prime al mondo) e la sua economia. Il presidente del Centro Europa Ricerche, Vladimiro Giacché, in Anschluss, (Annessione), ne fa un racconto dettagliato e terribile: l’unificazione si tradusse in una razzia a opera di aziende, banche, speculatori tedesco-occidentali e stranieri (alcune imprese acquisirono quelle concorrenti dell’Est, a volte molto migliori per qualità di prodotti e gestione, solo per chiuderle); città di grande tradizione industriale cessarono di esserlo in pochi mesi; milioni di posti di lavoro (poco meno di due, solo nel primo anno) andarono distrutti; la disoccupazione (abolita per norma costituzionale nella Germania orientale) è diventata la condizione adesso più diffusa. La Germania Est è oggi un paese assistito e viene paragonato al Mezzogiorno d’Italia. Cercate di immaginare cosa successe: da un giorno all’altro vengono sostituite la moneta e tutte le regole della nostra vita, della nostra comunità, il modo di produrre, chi comanda in città, nel paese, in azienda, a scuola. Chi lo fa, ci dice che è per unificare finalmente il paese; ed è vero. Ma è lui che decide come, con quale velocità, con quali norme. Nella nostra comunità ed economia arrivano a legioni gli unificatori, qualche idealista e molti affaristi: noi dobbiamo ancora capire come ci si muove nel mondo che stanno estendendo nel nostro; loro lo sanno già: è il loro mondo che estendono; non devono imparare niente. E quando c’è un dubbio, sono loro che lo risolvono: a proprio danno? I tedeschi avevano la stessa lingua, una storia comune che si era interrotta da pochi decenni, e una moneta che aveva lo stesso nome, pur se diverso valore. Ed è successo quel che è successo: l’economia dell’Est è di fatto cancellata, i tedesco-orientali hanno un livello di vita più basso di quelli occidentali, ma nemmeno quello potrebbero mantenere senza la pioggia di sussidi con cui li si mette in condizione di comprare, comprare, comprare, però senza fare. Ora immaginate la stessa cosa in Sardegna, con una dominazione spagnola che viene sostituita da quella sabauda (non avendo in comune niente: né storia, né lingua, né economia, né moneta); e, peggio ancora, nel Regno delle Due Sicilie, dove c’era uno stato autonomo, il più grande di quelli preunitari d’Italia, una società complessa, una storia ricchissima, una cultura tanto fertile e originale che ancor oggi riempie il mondo, un’economia sofisticata, già padrona delle più avanzate tecnologie del tempo. Ma, mentre le Germanie, Est e Ovest, da quando furono separate cominciarono a contare i giorni per la riunificazione, né la Sardegna né il Regno delle Due Sicilie chiedevano di essere annessi al Piemonte. Lasciate perdere le panzane che ci propinano da un secolo e mezzo sulla patriottica attesa dell’arrivo dei garibaldini e Vittorio Emanuele. Questo lo volevano i fuoriusciti napoletani a Torino, che erano il 7,6 per cento del totale, 1500, in gran parte lombardo-veneti: quindi, un centinaio di persone. E Luigi Carlo Farini (che da dittatore a Modena, per conto dei Savoia, si era impadronito dei beni del duca spodestato), da luogotenente a Napoli, scrisse che non erano più di 100 a volere l’unificazione. Come sosteneva anche Massimo D’Azeglio, che si chiedeva se fosse giusto prendere a «archibugiate» chi non voleva diventare piemontese. Per questo ci vollero tante stragi e tanti anni di guerra per “unificare” il Sud. Lo storico Emilio Gentile, in “Né stato né nazione”, a proposito delle celebrazioni della nostra Unità, rammenta che già dal primo giubileo, nel 1911, fecero «da stridente contrappunto la deprecazione dei mali non sanati e dei guasti prodotti dall’unificazione, avvenuta senza il consenso del popolo, con la condanna della Chiesa, per effetto di fortunate combinazioni esterne e non per necessaria e valida iniziativa interna». Eppure, quando il sogno coltivato dalle due Germanie pacificamente si avvera (mi trovavo lì il giorno in cui crollò il muro: li ho visti piangere, abbracciarsi, ubriachi di felicità. E di altro…), «la riunificazione rappresenta uno shock tremendo che provoca un crollo del pil», il prodotto interno lordo, delle regioni orientali, con una «riduzione complessiva superiore a un terzo» in soli due anni, scrivono Coniglio, Prota e Viesti. Be’, al Sud ci fu pure una lunga guerra; in Sardegna anni di stati d’assedio. Ma qualcuno ancora vuol dirci che se quelle economie sprofondarono e lo spirito della gente pure, fu perché “non sono come noi, signora”. Non si danno da fare. A me l’Italia va bene unita; l’Europa mi piace priva di frontiere; il mondo è più bello senza il muro di Berlino; la Cina meglio avercela concorrente commerciale che nemico nucleare. Ma le cose vanno raccontate per come sono, per come furono. Il raffronto fra quel che accadde in Sardegna con la Fusione Perfetta (in pratica, l’annessione al Piemonte), nel Regno delle Due Sicilie con la conquista da parte dei Savoia, e nella Germania Est con l’unificazione a quella Ovest, è impressionante: sistemi che si ripetono per sottrarre valore e capitali umani (costringendo i migliori all’emigrazione interna; o persino per eliminazione fisica, nel caso dell’ex Regno delle Due Sicilie); selezione della classe dirigente secondo la disponibilità ad adeguarsi al nuovo potere e servirlo, mortificando e rimuovendo chi non si adatta, con epurazioni feroci (nella Germania Est non si è arrivati alle fucilazioni, come da noi, ma qualcuno si è suicidato, altri hanno abbandonato il paese), per disabituare a decidere e dirigere e indurre all’obbedienza (grandi capi d’industria tedeschi orientali sono stati ridotti a direttori di filiali che attendono ordini da eseguire). In breve, detto con le parole di analisti tedeschi e stranieri: oggi, la Germania Est è una “colonia interna” di quella dell’Ovest, come il Mezzogiorno per l’Italia, la Sardegna per il Piemonte preunitario. Lo stesso presidente dell’Autorità cui fu affidata la liquidazione dell’economia dell’Est, la Treuhandanstalt, ammise a posteriori che «alcune imprese tedesco-occidentali si comportarono come ufficiali di un esercito coloniale». Con una differenza: l’Ovest (pur se a beneficio quasi esclusivo delle proprie imprese) ha investito nell’Est per realizzare infrastrutture, migliorare le condizioni abitative, dotare di un reddito sociale, servizi e assistenza i cittadini rimasti senza lavoro. In questo senso, la Germania ha fatto quel che in 150 anni l’Italia non ha fatto al Sud e il Piemonte e l’Italia non hanno fatto in Sardegna in tre secoli. «Un risultato sicuramente positivo nel processo di transizione della Germania orientale» avvertono Coniglio, Prota e Viesti nel loro studio «è la convergenza nella qualità della vita, nei consumi, come negli stili di vita. Inoltre, le regioni dell’Est dispongono di infrastrutture moderne, di un capitale umano di elevata qualità (in parte eredità della ex Repubblica democratica tedesca), di un sistema legale efficiente ed efficace». Dopo lo shock e il crollo per la riunificazione, il prodotto «pro capite della parte Est del paese passa dal 49 per cento del livello della Germania occidentale, nel 1991, al 67 per cento del 1996. Poiché molti dei trasferimenti provenienti dall’Ovest sono destinati a sostenere il consumo, il reddito disponibile pro capite raggiunge un livello notevolmente più alto, pari all’81-83 per cento». E questo divario fra quanto si produce e quanto si spende misura il grado di dipendenza dell’Est dall’Ovest, la sudditanza (sono io che ho in mano la qualità della tua vita… ): gli togli la possibilità (e, alla lunga, forse la capacità) di far da soli, meglio o peggio, si vedrà, gli togli quello che ha già, poi gli dai qualcosa, perché sia un buon consumatore, e deve dirti grazie. Il giorno in cui non conviene più farlo, perché c’è la crisi, perché ho ampliato i miei mercati e tu divieni meno importante (come gli ultimi vent’anni di governi italiani di rapina al Sud?), ti accuso di vivere alle mie spalle e ti tolgo quello che hai di più senza produrlo. Si tratta, secondo una descrizione del sociologo Jack Goody adattabilissima a queste vicende, di «rapporti di potere iniqui», che si trasformano «in uno scambio forzato, come in alcuni contesti coloniali o di conquista, nei quali un esercito invasore (e non sempre son necessarie le armi) prende ciò che vuole e lascia in cambio oggetti (o condizioni) dal valore irrisorio» (o molto precario). Torniamo all’essenziale: quello che crea parità è la volontà di raggiungerla e rispettarla. Il resto può persino trarre in inganno: la Germania Est è stata dotata di tutte le infrastrutture e i servizi la cui mancanza è ritenuta causa vera del ritardo nel Sud d’Italia, della Questione meridionale, eppure a 20 anni dal crollo del muro di Berlino è stato calcolato che per la vera “convergenza” (il termine con cui si dice che Est e Ovest saranno davvero alla pari) ce ne vorranno almeno altri 30. Ma la stima è considerata troppo ottimistica, perché secondo altre ricerche ci vorrà un secolo; mentre per la più importante rivista economica della Germania, l’edizione tedesca del «Financial Times», se non cambieranno le condizioni, bisognerà aspettare 320 anni! (La Sardegna passò sotto le cure di Torino e poi di Roma 290 anni fa.). Ma tu guarda quanto sono diventati “pigri” i tedeschi dell’Est e incapaci le loro “classi dirigenti coloniali”…. Pardon: “locali”……
di PINO APRILE


 Il mio buon amico Volkmann mi costringe di quando in quando a dissentire dalle sue opinioni. Egli afferma tra l’altro che a Napoli vi siano dai trenta ai quaranta mila oziosi. E quanti lo hanno ripetuto dopo di lui! Ma avendo io una certa conoscenza del Sud, ho subito sospettato che tale giudizio dipendesse dalla mentalità propria del Nord, dove si considerano oziosi tutti coloro che non s’affannano a lavorare tutto il santo giorno. Perciò ho osservato attentamente questo popolo napoletano, e ho potuto constatare che vi è molta gente mal vestita, ma nemmeno uno che sia disoccupato. Avevo chiesto spiegazioni ad alcuni amici del luogo su cosa facessero questi innumerevoli “vagabondi”, ma non ho ricevuto risposte soddisfacenti. Allora mi sono messo io stesso alla ricerca, mentre visitavo la città. Cominciai, in quell’enorme caos che è Napoli, a fare conoscenza con diversi tipi, inquadrandoli e classificandoli secondo il loro aspetto, il modo di vestire, di comportarsi, di operare.
Il mio buon amico Volkmann mi costringe di quando in quando a dissentire dalle sue opinioni. Egli afferma tra l’altro che a Napoli vi siano dai trenta ai quaranta mila oziosi. E quanti lo hanno ripetuto dopo di lui! Ma avendo io una certa conoscenza del Sud, ho subito sospettato che tale giudizio dipendesse dalla mentalità propria del Nord, dove si considerano oziosi tutti coloro che non s’affannano a lavorare tutto il santo giorno. Perciò ho osservato attentamente questo popolo napoletano, e ho potuto constatare che vi è molta gente mal vestita, ma nemmeno uno che sia disoccupato. Avevo chiesto spiegazioni ad alcuni amici del luogo su cosa facessero questi innumerevoli “vagabondi”, ma non ho ricevuto risposte soddisfacenti. Allora mi sono messo io stesso alla ricerca, mentre visitavo la città. Cominciai, in quell’enorme caos che è Napoli, a fare conoscenza con diversi tipi, inquadrandoli e classificandoli secondo il loro aspetto, il modo di vestire, di comportarsi, di operare.